da la domenica di repubblica del 26.1.2014
N,b
Raccolti in A Lakota War Book
from The Little Bighorn
(Peabody Museum Press)
i disegni qui pubblicati
sono stati ritrovati nella tomba
di un capo indiano sepolto
a Little Bighorn .
E qui gli ho riportati tramite il cattura immagine \ Png se ai puristi non dovesse piacere come gli ho riportasti può andare all'articolo originale dell'inserto
Battaglie, libere cavalcate e battute di caccia. Riemergono dopo quasi un secolo di oblio
le imprese dei nativi americani negli anni di Little Bighorn
Stavolta non raccontate dalla propaganda dei film americani
ma disegnate su taccuini rubati ai “visi pallidi” da guerrieri Sioux e Cheyenne
SIEGMUND GINZBERG
Il giornalista ci ricamò una storia. Mischiò notizie vere ad altre di sua invenzione. Scrisse che l’album era stato rinvenuto in una sepoltura indiana
a Little Bighorn, il sito della battaglia in cui i Sioux avevano annientato Custer e il suo Settimo Cavalleggeri. Ed era vero. Che i disegni erano stati eseguiti sulle pagine di un libro mastro sottratto a un viaggiatore bianco ucciso su uno dei più famosi sentieri per il West, il Bozeman trail. Ed era vero. Che la serie di settantasette disegni rappresentava le
gesta, era l’autobiografia, di un capo di nome Mezza Luna. Era solo verosimile.
Ledger books vengono chiamati gli album disegnati dagli “indiani” di metà Ottocento sulle pagine già usate di quaderni e registri contabili (ledger appunto), o addirittura sui
fogli dei ruolini dell’esercito Usa, spesso sovrapponendoli a quanto vi potesse già essere scritto. Il “supporto” artistico era preda di guerra, e ciò ne aumentava enormemente il valore agli occhi dei possessori.
Esattamente come per gli indiani delle praterie i cavalli sottratti ai bianchi, o meglio ancora acquisiti in combattimento, valevano molto più di quelli domati da un branco selvaggio. Era una questione di status, anzi di logo, di marca, verrebbe da dire. Al punto che, in mancanza di prede con marchi autentici,i giovani guerrieri solevano dipingere il marchio “US Army” sui propri cavalli.
È il western per una volta raccontato dagli invasi (i nativi) e non dagli invasori (i coloni europei difesi dall’esercito),la guerra raccontata dagli sconfitti e non dai vincitori. Dipingere o farsi dipingere le proprie imprese di guerra e i propri fatti di coraggio, su quaderni e registri sottratti ai bianchi, non era solo un must, lo status symbol per eccellenza. Era anche possesso di un oggetto magico,propiziatorio.
Anche se a un certo punto divenne scomodo, perché gli album cominciarono a essere usati nei processi come prova di partecipazione a banda armata.
Tra i molti album del genere che si sono conservati,questo le cui immagini qui pubblichiamo è ancora più speciale.
Perché non è opera di un unico autore. È uno scambio di cortesie cerimoniali a più mani. Gli artisti, Sioux e Cheyenne, che raccontano le proprie imprese o quelle dei propri amici, in questa raccolta sono almeno sei. E uno di loro potrebbe essere niente meno che il leggendario capo guerriero Nuvola Rossa. Così almeno sostiene l’antropologo Castle McLaughlin nel suo dotto commento alla riproduzione a stampa dell’album, col titolo A Lakota War Book from The Little Bighorn pubblicato dalla Peabody Museum Press e dalla Houghton Library dell’Università di Harvard che ne detiene l’originale. Il sottotitolo: The Pictographic“Autobiography of Half Moon”,si riferisce al titolo che alla raccolta era stato dato da un reporter del Chicago Tribune, inviato (oggi si direbbe embedded)
al seguito delle truppe dell’esercito impegnate contro le tribù di indiani, che l’aveva fatta rilegare elegantemente,aggiungendovi una sua introduzione in bella calligrafia. Phocion
Howard - questo lo pseudonimo con cui il giornalista firmava dal fronte - sosteneva di aver avuto i disegni da un sergente del Secondo Cavalleria, uno dei reparti arrivati sul campo della battaglia di Little Bighorn in soccorso di Custer quando ormai il generale e il suo reparto erano stati annientati, il 28 giugno 1876. Il quaderno da contabile a righine
con le pagine dipinte faceva parte del corredo funerario di un capo indiano,rimasto ucciso probabilmente in un altro scontro, di appena qualche giorno prima.
Era frequente che i soldati blu recuperassero come souvenir dai cadaveri e dai monumenti funerari degli indiani uccisi album di disegni tipo questo.
Talvolta venivano venduti ai turisti, altre volte considerati carta straccia con scarabocchi. Questo si salvò, anzi fu curato con un eccesso di attenzioni.
Howard lo fece smembrare e ricomporre in modo che sembrasse un’unica narrazione autobiografica.
E si inventò un personaggio inesistente. Per sbaglio, perché aveva equivocato come nome proprio un simbolo di mezza luna su uno dei dipinti.
Oppure perché riteneva che potesse interessare maggiormente se rispondeva ai gusti di una narrazione all’europea.
Oppure forse perché sperava
che potesse riscuotere un successo di pubblico simile a quello di un’altra “biografia per immagini” che fece furore sulla stampa americana proprio nei giorni successivi allo shock per la fine di Custer e dei suoi soldati: quella di Toro Seduto. Era stato il New York Herald a
pubblicare il 9 luglio 1876, giusto pochi giorni dopo Little Bighorn, alcuni dei disegni di «fatti di sangue, crudeltà, ruberie, disumanità,barbarie» tratti dall'autobiografia disegnata di suo pugno del gran capo Sioux. Era un modo per incitare all’odio nei confronti dei “pellerossa” e a farla finita una volta per tutte con quei “selvaggi”, responsabili di tali atrocità. E in effetti l’essersi poi arreso,anzi integrato fino al punto di esibirsi nel circo
di Buffalo Bill, non aveva evitato al vecchio e moderato Toro Seduto di fare la fine di Osama bin Laden. Esattamente come finì ammazzato,quando si era già consegnato,l’irriducibile “testa calda” Cavalo Pazzo.Non a caso era stato lo stesso giornale a condurre una campagna contro la “politica di pace” di Washington nei confronti dei “ribelli”, denunciando —con l’aiuto di Custer, che quasi ci rimise la carriera per l’indiscrezione — lo scandalo di un traffico di licenze sulle riserve indiane in cui era implicato lo stesso fratello del presidente Grant.
L’album, il ledger book di Howard,aveva invece il difetto di evocare al pubblicopiù l’eroismo romantico dell’Ultimo mohicano di Fenimore Cooper che l’orrore per la barbarie del selvaggio.
Illustra le imprese compiute negli anni delle “guerre di Nuvola Rossa”, nel corso del decennio precedente i fatti di Little Bighorn. Fatti militari, certo, ma anche imprese di caccia, dove l’elemento principale non è affatto la crudeltà o la truculenza ma il coraggio. Scorre sangue, vengono uccisi soldati e ufficiali in divisa, anche civili e donne, e soprattutto altri indiani: le odiate guide Shoshone che accompagnavano la cavalleria Usa, o membri di tribù avversarie dei Sioux. Ma l’accento è immancabilmente sul coraggio, sul cavalcare in mezzo a nugoli di frecce e proiettili, sul
rubare sotto il fuoco i cavalli e i muli dell’esercito, sull'aiutare i compagni che hanno perso la cavalcatura, sulla pratica del “contare i colpi” sul nemico, semplicemente toccandolo, mentre è ancora vivo o impugna un’arma, con la punta della lancia o dell’arco. Per questi cavalieri della prateria la guerra è un gioco, un rito, una questione di faccia e di onore, un po’ come i romanzi europei ci avevano fatto immaginare dovesse esserlo per i cavalieri erranti del medioevo. C’è anche una storia d’amore,
di rapimento della donzella da parte dell’innamorato, ma solo in un disegno su settantasette. Ma non è neppure solo un romanzo, una graphic novel. Il curatore insiste
con dovizia di argomenti, attenzione meticolosa ai particolari (dalle armi al vestiario, alle finiture dei cavalli e ai colori di guerra) a trattarlo come un eccezionale documento storico, legato a fatti e protagonisti storici. Eppure nel suo secolo ebbe notorietà brevissima. Passò di mano in mano prima di arrivare nel 1930 alla biblioteca dell’Università di Harvard. E lì fu dimenticato per quasi un secolo. Malgrado l’America
avesse nel frattempo riscoperto una nostalgia struggente per la civiltà sottoposta a sterminio etnico dei suoi cavalieri della prateria.
L’alfabeto delle grandi pianure VITTORIO ZUCCONI
In principio era l’immagine. Non erano la parola, il verbo, ma le immagini che accendevano l’universo materiale e spirituale dei popoli delle grandi pianure, che segnavano la loro identità di Piccole Lune, Grandi Alci, Cavalli Pazzi, Volpe Macchiata, che marcavano il tempo e il gelo degli inverni, che ricordavano ai bambini gli eventi straordinari, come “la notte in cui cadde il cielo”, quando centinaia di meteoriti illuminarono il buio della prateria nel 1870. E, naturalmente,le guerre.
Per la nazione che noi chiamiamo, da una storpiatura francofona, Sioux, per i Lakota, come loro si chiamano, per i loro alleati Cheyenne e Arapaho, il 25 giugno del 1876 fu una sequenza di immagini, da narrare per generazioni sulle pelli di bisonte e di daino e da leggere come ai nostri scolari si leggono le imprese di Giulio Cesare o le Guerre d’Indipendenza. Quando i primi distaccamenti del Settimo Cavalleria attaccarono il grande campo estivo nel territorio del Montana, scatenando due giorni di massacri per proteggere dallo sterminio i cinquemila fra bambini,vecchi e donne raccolti là, non c’erano storici con papiri e tavolette di cera per registrare l’ultima vittoria del popolo della prateria e lo sterminio della colonna del colonnello George Armstrong Custer. C’erano uomini, stranamente sempre e soltanto uomini, incaricati d’imprimersi nella memoria quello che avrebbero poi trascritto nei pittogrammi sulle pelli e sulla carta.L’alfabeto dei nativi del Nord America, che non avevano lingua scritta, era quello. In attesa di traslitterare nei caratteri latini degli invasori le loro parole, l’immagine era la storia, il video,la sequenza, a volte lineare, altre volte chiusa nei cerchi concentrici dei calendari, per dare il senso del tempo come nei tronchi d’albero. Segnalavano le rotte, i percorsi, le transumanze dei bisonti, graffiati in permanenza sulle rocce. Avvertivano dei pericoli, di possibili agguati dei “dragoni” in blu, dipinti su pelli fermate da sassi, che gli altri Lakota — ma non i bianchi — sapevano leggere e interpretare, misurando l’imminenza del rischio dalla freschezza delle pelli e dei segni. Non c’è neppure bisogno di essere un Lakota, un Oglala, un Cheyenne per capire la potenza immemore delle immagini. Sulle rive del contorto Little Bighorn, oltre le fila di lapidi bianche che segnalano le tombe dei 263 soldati condotti alla morte da Custer (ma non la sua, che è all'Accademia di West Point), c’è una fossa di terra, come una trincea improvvisata. Fu in quella buca, scavata nella terra soffice dell’estate, che il distaccamento di rinforzo del colonnello Reno, prudentemente rimasto indietro, resistette per due giorni alla furia degli indiani. Sui bordi della buca, nel lato rivolto verso il fiume del sangue, ancora oggi, un secolo e mezzo più tardi, si vedono bene le fossette scavate dai soldati per usarle come cavalletti naturali, per poggiare le loro carabine e mirare meglio, risparmiando le scarse munizioni. Neppure l’erba, che nel gelo del grande nord cresce avara, le ha nascoste. Guardandole, si sentono gli spari, le grida dei feriti,gli ordini, le urla terrorizzanti — e terrorizzate — dei guerrieri lanciati sulla collina. Perché avevano ragione loro, i figli delle grandi pianure. Sono le immagini che ci sanno parlare più forte delle parole.
Raccolti in A Lakota War Book
from The Little Bighorn
(Peabody Museum Press)
i disegni qui pubblicati
sono stati ritrovati nella tomba
di un capo indiano sepolto
a Little Bighorn .
E qui gli ho riportati tramite il cattura immagine \ Png se ai puristi non dovesse piacere come gli ho riportasti può andare all'articolo originale dell'inserto
le imprese dei nativi americani negli anni di Little Bighorn
Stavolta non raccontate dalla propaganda dei film americani
ma disegnate su taccuini rubati ai “visi pallidi” da guerrieri Sioux e Cheyenne
SIEGMUND GINZBERG
Il giornalista ci ricamò una storia. Mischiò notizie vere ad altre di sua invenzione. Scrisse che l’album era stato rinvenuto in una sepoltura indiana
a Little Bighorn, il sito della battaglia in cui i Sioux avevano annientato Custer e il suo Settimo Cavalleggeri. Ed era vero. Che i disegni erano stati eseguiti sulle pagine di un libro mastro sottratto a un viaggiatore bianco ucciso su uno dei più famosi sentieri per il West, il Bozeman trail. Ed era vero. Che la serie di settantasette disegni rappresentava le
gesta, era l’autobiografia, di un capo di nome Mezza Luna. Era solo verosimile.
Ledger books vengono chiamati gli album disegnati dagli “indiani” di metà Ottocento sulle pagine già usate di quaderni e registri contabili (ledger appunto), o addirittura sui
fogli dei ruolini dell’esercito Usa, spesso sovrapponendoli a quanto vi potesse già essere scritto. Il “supporto” artistico era preda di guerra, e ciò ne aumentava enormemente il valore agli occhi dei possessori.
Esattamente come per gli indiani delle praterie i cavalli sottratti ai bianchi, o meglio ancora acquisiti in combattimento, valevano molto più di quelli domati da un branco selvaggio. Era una questione di status, anzi di logo, di marca, verrebbe da dire. Al punto che, in mancanza di prede con marchi autentici,i giovani guerrieri solevano dipingere il marchio “US Army” sui propri cavalli.
È il western per una volta raccontato dagli invasi (i nativi) e non dagli invasori (i coloni europei difesi dall’esercito),la guerra raccontata dagli sconfitti e non dai vincitori. Dipingere o farsi dipingere le proprie imprese di guerra e i propri fatti di coraggio, su quaderni e registri sottratti ai bianchi, non era solo un must, lo status symbol per eccellenza. Era anche possesso di un oggetto magico,propiziatorio.
Anche se a un certo punto divenne scomodo, perché gli album cominciarono a essere usati nei processi come prova di partecipazione a banda armata.
Tra i molti album del genere che si sono conservati,questo le cui immagini qui pubblichiamo è ancora più speciale.
Perché non è opera di un unico autore. È uno scambio di cortesie cerimoniali a più mani. Gli artisti, Sioux e Cheyenne, che raccontano le proprie imprese o quelle dei propri amici, in questa raccolta sono almeno sei. E uno di loro potrebbe essere niente meno che il leggendario capo guerriero Nuvola Rossa. Così almeno sostiene l’antropologo Castle McLaughlin nel suo dotto commento alla riproduzione a stampa dell’album, col titolo A Lakota War Book from The Little Bighorn pubblicato dalla Peabody Museum Press e dalla Houghton Library dell’Università di Harvard che ne detiene l’originale. Il sottotitolo: The Pictographic“Autobiography of Half Moon”,si riferisce al titolo che alla raccolta era stato dato da un reporter del Chicago Tribune, inviato (oggi si direbbe embedded)
al seguito delle truppe dell’esercito impegnate contro le tribù di indiani, che l’aveva fatta rilegare elegantemente,aggiungendovi una sua introduzione in bella calligrafia. Phocion
Howard - questo lo pseudonimo con cui il giornalista firmava dal fronte - sosteneva di aver avuto i disegni da un sergente del Secondo Cavalleria, uno dei reparti arrivati sul campo della battaglia di Little Bighorn in soccorso di Custer quando ormai il generale e il suo reparto erano stati annientati, il 28 giugno 1876. Il quaderno da contabile a righine
con le pagine dipinte faceva parte del corredo funerario di un capo indiano,rimasto ucciso probabilmente in un altro scontro, di appena qualche giorno prima.
Era frequente che i soldati blu recuperassero come souvenir dai cadaveri e dai monumenti funerari degli indiani uccisi album di disegni tipo questo.
Talvolta venivano venduti ai turisti, altre volte considerati carta straccia con scarabocchi. Questo si salvò, anzi fu curato con un eccesso di attenzioni.
Howard lo fece smembrare e ricomporre in modo che sembrasse un’unica narrazione autobiografica.
E si inventò un personaggio inesistente. Per sbaglio, perché aveva equivocato come nome proprio un simbolo di mezza luna su uno dei dipinti.
Howard lo fece smembrare e ricomporre in modo che sembrasse un’unica narrazione autobiografica.
E si inventò un personaggio inesistente. Per sbaglio, perché aveva equivocato come nome proprio un simbolo di mezza luna su uno dei dipinti.
Oppure perché riteneva che potesse interessare maggiormente se rispondeva ai gusti di una narrazione all’europea.
Oppure forse perché sperava
che potesse riscuotere un successo di pubblico simile a quello di un’altra “biografia per immagini” che fece furore sulla stampa americana proprio nei giorni successivi allo shock per la fine di Custer e dei suoi soldati: quella di Toro Seduto. Era stato il New York Herald a
pubblicare il 9 luglio 1876, giusto pochi giorni dopo Little Bighorn, alcuni dei disegni di «fatti di sangue, crudeltà, ruberie, disumanità,barbarie» tratti dall'autobiografia disegnata di suo pugno del gran capo Sioux. Era un modo per incitare all’odio nei confronti dei “pellerossa” e a farla finita una volta per tutte con quei “selvaggi”, responsabili di tali atrocità. E in effetti l’essersi poi arreso,anzi integrato fino al punto di esibirsi nel circo
di Buffalo Bill, non aveva evitato al vecchio e moderato Toro Seduto di fare la fine di Osama bin Laden. Esattamente come finì ammazzato,quando si era già consegnato,l’irriducibile “testa calda” Cavalo Pazzo.Non a caso era stato lo stesso giornale a condurre una campagna contro la “politica di pace” di Washington nei confronti dei “ribelli”, denunciando —con l’aiuto di Custer, che quasi ci rimise la carriera per l’indiscrezione — lo scandalo di un traffico di licenze sulle riserve indiane in cui era implicato lo stesso fratello del presidente Grant.
L’album, il ledger book di Howard,aveva invece il difetto di evocare al pubblicopiù l’eroismo romantico dell’Ultimo mohicano di Fenimore Cooper che l’orrore per la barbarie del selvaggio.
Illustra le imprese compiute negli anni delle “guerre di Nuvola Rossa”, nel corso del decennio precedente i fatti di Little Bighorn. Fatti militari, certo, ma anche imprese di caccia, dove l’elemento principale non è affatto la crudeltà o la truculenza ma il coraggio. Scorre sangue, vengono uccisi soldati e ufficiali in divisa, anche civili e donne, e soprattutto altri indiani: le odiate guide Shoshone che accompagnavano la cavalleria Usa, o membri di tribù avversarie dei Sioux. Ma l’accento è immancabilmente sul coraggio, sul cavalcare in mezzo a nugoli di frecce e proiettili, sul
pubblicare il 9 luglio 1876, giusto pochi giorni dopo Little Bighorn, alcuni dei disegni di «fatti di sangue, crudeltà, ruberie, disumanità,barbarie» tratti dall'autobiografia disegnata di suo pugno del gran capo Sioux. Era un modo per incitare all’odio nei confronti dei “pellerossa” e a farla finita una volta per tutte con quei “selvaggi”, responsabili di tali atrocità. E in effetti l’essersi poi arreso,anzi integrato fino al punto di esibirsi nel circo
di Buffalo Bill, non aveva evitato al vecchio e moderato Toro Seduto di fare la fine di Osama bin Laden. Esattamente come finì ammazzato,quando si era già consegnato,l’irriducibile “testa calda” Cavalo Pazzo.Non a caso era stato lo stesso giornale a condurre una campagna contro la “politica di pace” di Washington nei confronti dei “ribelli”, denunciando —con l’aiuto di Custer, che quasi ci rimise la carriera per l’indiscrezione — lo scandalo di un traffico di licenze sulle riserve indiane in cui era implicato lo stesso fratello del presidente Grant.
L’album, il ledger book di Howard,aveva invece il difetto di evocare al pubblicopiù l’eroismo romantico dell’Ultimo mohicano di Fenimore Cooper che l’orrore per la barbarie del selvaggio.
Illustra le imprese compiute negli anni delle “guerre di Nuvola Rossa”, nel corso del decennio precedente i fatti di Little Bighorn. Fatti militari, certo, ma anche imprese di caccia, dove l’elemento principale non è affatto la crudeltà o la truculenza ma il coraggio. Scorre sangue, vengono uccisi soldati e ufficiali in divisa, anche civili e donne, e soprattutto altri indiani: le odiate guide Shoshone che accompagnavano la cavalleria Usa, o membri di tribù avversarie dei Sioux. Ma l’accento è immancabilmente sul coraggio, sul cavalcare in mezzo a nugoli di frecce e proiettili, sul
rubare sotto il fuoco i cavalli e i muli dell’esercito, sull'aiutare i compagni che hanno perso la cavalcatura, sulla pratica del “contare i colpi” sul nemico, semplicemente toccandolo, mentre è ancora vivo o impugna un’arma, con la punta della lancia o dell’arco. Per questi cavalieri della prateria la guerra è un gioco, un rito, una questione di faccia e di onore, un po’ come i romanzi europei ci avevano fatto immaginare dovesse esserlo per i cavalieri erranti del medioevo. C’è anche una storia d’amore,
di rapimento della donzella da parte dell’innamorato, ma solo in un disegno su settantasette. Ma non è neppure solo un romanzo, una graphic novel. Il curatore insiste
con dovizia di argomenti, attenzione meticolosa ai particolari (dalle armi al vestiario, alle finiture dei cavalli e ai colori di guerra) a trattarlo come un eccezionale documento storico, legato a fatti e protagonisti storici. Eppure nel suo secolo ebbe notorietà brevissima. Passò di mano in mano prima di arrivare nel 1930 alla biblioteca dell’Università di Harvard. E lì fu dimenticato per quasi un secolo. Malgrado l’America
avesse nel frattempo riscoperto una nostalgia struggente per la civiltà sottoposta a sterminio etnico dei suoi cavalieri della prateria.
L’alfabeto delle grandi pianure VITTORIO ZUCCONI
In principio era l’immagine. Non erano la parola, il verbo, ma le immagini che accendevano l’universo materiale e spirituale dei popoli delle grandi pianure, che segnavano la loro identità di Piccole Lune, Grandi Alci, Cavalli Pazzi, Volpe Macchiata, che marcavano il tempo e il gelo degli inverni, che ricordavano ai bambini gli eventi straordinari, come “la notte in cui cadde il cielo”, quando centinaia di meteoriti illuminarono il buio della prateria nel 1870. E, naturalmente,le guerre.
Per la nazione che noi chiamiamo, da una storpiatura francofona, Sioux, per i Lakota, come loro si chiamano, per i loro alleati Cheyenne e Arapaho, il 25 giugno del 1876 fu una sequenza di immagini, da narrare per generazioni sulle pelli di bisonte e di daino e da leggere come ai nostri scolari si leggono le imprese di Giulio Cesare o le Guerre d’Indipendenza. Quando i primi distaccamenti del Settimo Cavalleria attaccarono il grande campo estivo nel territorio del Montana, scatenando due giorni di massacri per proteggere dallo sterminio i cinquemila fra bambini,vecchi e donne raccolti là, non c’erano storici con papiri e tavolette di cera per registrare l’ultima vittoria del popolo della prateria e lo sterminio della colonna del colonnello George Armstrong Custer. C’erano uomini, stranamente sempre e soltanto uomini, incaricati d’imprimersi nella memoria quello che avrebbero poi trascritto nei pittogrammi sulle pelli e sulla carta.L’alfabeto dei nativi del Nord America, che non avevano lingua scritta, era quello. In attesa di traslitterare nei caratteri latini degli invasori le loro parole, l’immagine era la storia, il video,la sequenza, a volte lineare, altre volte chiusa nei cerchi concentrici dei calendari, per dare il senso del tempo come nei tronchi d’albero. Segnalavano le rotte, i percorsi, le transumanze dei bisonti, graffiati in permanenza sulle rocce. Avvertivano dei pericoli, di possibili agguati dei “dragoni” in blu, dipinti su pelli fermate da sassi, che gli altri Lakota — ma non i bianchi — sapevano leggere e interpretare, misurando l’imminenza del rischio dalla freschezza delle pelli e dei segni. Non c’è neppure bisogno di essere un Lakota, un Oglala, un Cheyenne per capire la potenza immemore delle immagini. Sulle rive del contorto Little Bighorn, oltre le fila di lapidi bianche che segnalano le tombe dei 263 soldati condotti alla morte da Custer (ma non la sua, che è all'Accademia di West Point), c’è una fossa di terra, come una trincea improvvisata. Fu in quella buca, scavata nella terra soffice dell’estate, che il distaccamento di rinforzo del colonnello Reno, prudentemente rimasto indietro, resistette per due giorni alla furia degli indiani. Sui bordi della buca, nel lato rivolto verso il fiume del sangue, ancora oggi, un secolo e mezzo più tardi, si vedono bene le fossette scavate dai soldati per usarle come cavalletti naturali, per poggiare le loro carabine e mirare meglio, risparmiando le scarse munizioni. Neppure l’erba, che nel gelo del grande nord cresce avara, le ha nascoste. Guardandole, si sentono gli spari, le grida dei feriti,gli ordini, le urla terrorizzanti — e terrorizzate — dei guerrieri lanciati sulla collina. Perché avevano ragione loro, i figli delle grandi pianure. Sono le immagini che ci sanno parlare più forte delle parole.







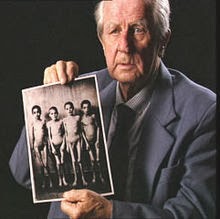

.gif)














