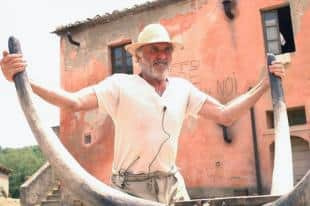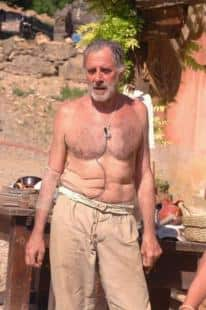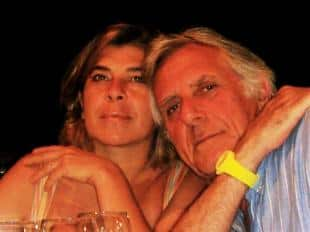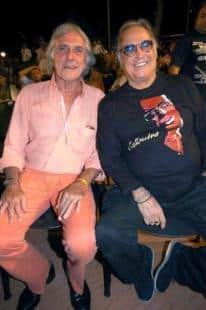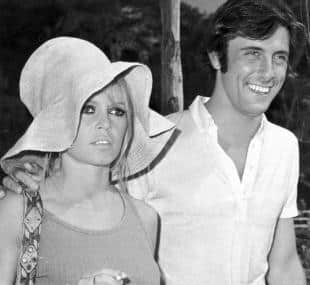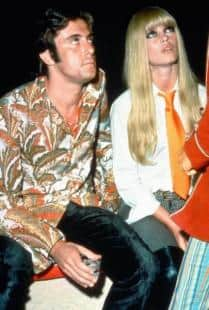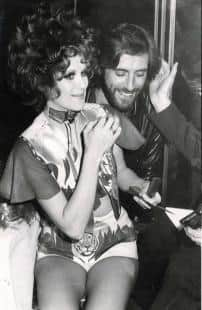Per chi ha tempo e vuole saperne di più oltre all'introduzione , ai siti riportati a fine post , e all'articolo riportato integralmente dal IL FOGLIO in cui racconta in maniera più dettagliata la vicenda e sul fango gettatogli addosso per evitare che parlasse di ciò . Ringrazio il libro : C'era una volta in Italia gli anni sessanta di Enrico Deaglio per aver fatto conoscere tale storia
Per le storie d'oggi vi propongo la storia di prof. Vincenzo Mario Palmieri (nato a Brescia il 16.07.1899 e deceduto a Napoli il 23.12.1993) che fu docente di medicina legale presso l’ateneo napoletano dal 1940 al 1969 e sindaco di Napoli tra il 1962 ed il 1963. Il prof. Palmieri fu componente di quella che potremmo definire la prima commissione internazionale nominata per l’accertamento di crimini di
guerra durante la seconda guerra mondiale. “Vincenzo Mario Palmieri, il medico napoletano che smascherò la bugia di Katyn, viene ricordato in Polonia come un eroe”, attesta Alfonso Maffettone che è stato corrispondente dell’Ansa a Varsavia per sei anni, dal 1993 al 1999, e mantiene tuttora contatti in quel Paese… “Non solo contribuì con la sua perizia alla rivelazione di uno dei più grandi crimini di Stalin”, aggiunge il giornalista (che per l’agenzia di stampa internazionale ha lavorato anche da New York, Tokyo, Singapore), “ ma ebbe la forza, sottolineano i polacchi, di resistere alle persecuzioni e alle minacce degli agenti del servizio segreto russo (Nkvd e Kgb) che, sotto falsa identità, venivano a Napoli per farsi consegnare dal medico una dichiarazione con la smentita ufficiale dei suoi studi da cui emergeva la responsabilità dei sovietici del massacro di Katyn”. Palmieri era pedinato, minacciato, anche affinchè non fosse divulgata la sua testimonianza “scomoda”. Si parla della strage di 22mila ufficiali polacchi sepolti nella foresta di Katyn, nei pressi della città di Smolensk (Russia) durante la seconda guerra mondiale. I cadaveri furono scoperti nel 1943 e, dopo uno scambio di accuse tra Russia e Germania sulle responsabilità dell’eccidio, si riuscì ad accertare la verità soltanto in seguito alle perizie di una commissione internazionale di scienziati indipendenti nella quale ebbe un ruolo determinante proprio il medico legale, docente della Federico II, Vincenzo Mario Palmieri appunto .
da il foglio
Upon all the living and the dead (J. Joyce)
Il giuramento di Ippocrate vale su tutti i vivi e i morti, anche se i morti non possono guarire né parlare, rimproverare o denunciare. Per non tradire i morti il professor Vincenzo Mario Palmieri, di anni 44, affermato docente napoletano di medicina legale, avrebbe vissuto il mezzo secolo che ancora gli riservò il destino nel timore di essere ucciso, nella denigrazione e in un inesplicabile silenzio. Sperò che tutti dimenticassero di lui ciò che lui non avrebbe mai dimenticato: “Uno spettacolo grandiosamente sinistro, che richiederebbe il verso di Dante o il pennello di Michelangelo”. E che richiese, a Palmieri, un referto scientifico di cui forse si pentì ma non avrebbe ritrattato.
E’ mercoledì 28 aprile 1943 quando il professore, assieme a 12 colleghi di altrettanti paesi, scende dal bus che lo ha portato dalla città russa di Smolensk alla vicina foresta di Katyn, dove le truppe tedesche di occupazione vanno scoprendo un immane massacro. Giacciono accatastati sotto un metro e mezzo di terra sabbiosa, su cui giovani pini e betulle sono stati trapiantati, i corpi di circa ventiduemila militari polacchi perlopiù ufficiali, prigionieri di guerra dei sovietici. Li ha liquidati la polizia segreta Nkvd, secondo un piano che poi si accerterà disposto dal Politburo e curato dal ministro dell’Interno Laurenti Beria. La Germania di Hitler, cui è offerta una formidabile opportunità propagandistica, incolpa della strage i sovietici. La Russia di Stalin respinge l’accusa e attribuisce il crimine ai nazisti. Gli alleati occidentali acconsentono per convenienza alla versione di Mosca. Il governo di Polonia esule a Londra sollecita un’indagine indipendente e il Cremlino, considerando la richiesta un atto ostile, rompe le relazioni diplomatiche con i polacchi. E’ in questo clima che il 23 aprile del ’43 la Croce rossa internazionale apre il Caso Katyn e designa una commissione per stabilire la dinamica del massacro e soprattutto la data: se sia avvenuto prima o dopo l’arrivo dei nazisti.
Per l’ignaro Palmieri la vita sta per cambiare: è stato scelto come rappresentante italiano per caratura accademica e perché parla tre lingue fra cui il tedesco, usato anche in casa con la moglie svizzera Erna Irene von Wattenwyl. Il 24 aprile, Sabato Santo, ha appena comprato la pastiera quando riceve una telefonata che lo invita subito a partire “onde procedere ad un’inchiesta medico-legale sui cadaveri esumati in gran copia nella foresta di Katyn”. La domenica di Pasqua si mette in treno e arriva a Roma, dove viene imbarcato su un aereo per Berlino. Vola martedì 27 via Varsavia a Smolensk con i colleghi, tranne il delegato spagnolo: il professor Piga, racconterà Palmieri, “aveva talmente sofferto nel viaggio in aereo che non riteneva possibile proseguire”. Qualche altro membro della commissione, potendo leggere il futuro, ne avrebbe seguito l’esempio. Come il professor Hayek di Praga. O Markov di Sofia. Quando i rispettivi paesi cadranno sotto influenza sovietica ritireranno le firme dalla perizia, poi finiranno uccisi. Più impressione ancora desterà in Palmieri, nel dopoguerra, la morte misteriosa del generale medico francese Costeodat, che aveva preso parte da osservatore alla commissione.
La perizia conclusiva della Croce rossa, siglata all’unanimità, non lasciava adito a dubbi: lo sterminio ebbe luogo tra marzo e aprile 1940 e si trattò, scrisse Palmieri, “di un’esecuzione sistematica, realizzata da persone particolarmente esperte”. Gli esami medici, botanici, balistici, coincidenti con le testimonianze raccolte fra la popolazione, trovavano conferma nelle carte rinvenute sui corpi, riferibili a un’epoca compresa tra l’autunno ’39 e l’aprile successivo. La maggioranza delle salme fu identificata facilmente perché i militari, caricati a gruppi sui camion dai campi di prigionia al luogo dell’esecuzione, vestivano la propria uniforme invernale e conservavano portafogli e documenti personali.
E’ mercoledì 28 aprile 1943. Vincenzo Mario Palmieri scende dal bus che lo ha portato dove i tedeschi hanno scoperto un immane massacro
Alla riconquista del territorio, il Cremlino nominerà la commissione medica Burdenko sotto suo diretto controllo, che sosterrà la matrice nazista dell’eccidio con un’opera di manipolazione dagli effetti duraturi, anche se nel mondo occidentale le reticenze cadono e nel 1951 un’inchiesta promossa dal Congresso americano accerta l’esistenza di “prove definitive e inequivocabili” contro i sovietici. Bisognerà aspettare la caduta del Muro di Berlino perché a Mosca ammettano le responsabilità: solo nel 1990 Gorbaciov porge le scuse ufficiali alla Polonia e nel ’92 Eltsin desecreta parte degli archivi tra cui i documenti su Katyn. Magari il professor Palmieri, che muore il 23 dicembre del ’94 ancora lucido malgrado un ictus sofferto anni prima, avrà guardato con sollievo a questa conclusione. Se lo fece, s’illuse. Perché non era (non è) finita. Nel 2004 Putin impone nuovamente il segreto di stato sulle carte, che sono un tassello dei complessi rapporti tra la Russia e la Polonia, e quando poi deplorerà l’eccidio ne parlerà come di un crimine stalinista (prima di rivalutare Stalin stesso).
Ma ormai nell’Italia degli anni Duemila nessuno si ricorda più dell’uomo che stese di suo pugno il primo referto su Katyn, lavorando su quel testo con i colleghi fino all’alba. Nessuno si ricorda o quasi: il 10 ottobre 2004, rispondendo a un lettore sul Corriere della Sera, Paolo Mieli ripercorre la vicenda e osserva che “i sovietici si impegnarono a screditare chiunque avesse collaborato con quella commissione”. Cita un’opera fondamentale, Il massacro di Katyn di Victor Zaslavsky, in cui si riferiva “dell’intimidazione e della denigrazione comunista nei confronti del professore napoletano Vincenzo Mario Palmieri che si era occupato del caso. E che, per essersi avvicinato alla verità e averne parlato pubblicamente, fu definito dal Pci ‘collaborazionista’, ‘fascista’, ‘nazista’, ‘servo della propaganda di Goebbels’, ‘menzognero e falsificatore della verità storica’. Una storia molto triste”.
Bisogna aspettare la caduta del Muro perché a Mosca ammettano le responsabilità. Nel 2004 Putin impone di nuovo il segreto di stato sulle carte
Molto triste sì ma adesso, aprile 2022, sembra tutto lontano: è lontano il luglio del ’43, quando il generale polacco Wladyslaw Sikorski, che ha chiesto conto a Stalin dell’eccidio, muore in un misterioso incidente aereo. Lontano il marzo ’46, quando il procuratore di Cracovia Roman Martini, che indaga su Katyn, viene ucciso sotto casa. Lontano persino il 10 aprile 2010, quando il presidente della Repubblica polacca, Lech Kaczynski, perisce con altre 95 persone (tra cui i membri dello stato maggiore) mentre vola a Smolensk per commemorare le vittime. Ma lontano molto meno è maggio 2020, quando vengono rimosse le targhe che ricordavano la strage dall’ex edificio dell’Nkvd, alla vigilia del settantacinquesimo anniversario della vittoria sul nazismo. E lontana per nulla, bensì di questi giorni, è la conclusione della commissione d’inchiesta polacca sulla fine di Kaczynski, che ribaltando le precedenti indagini non attribuisce il disastro a errori umani ma a due esplosioni sul Tupolev presidenziale, di cui i russi si sono sempre rifiutati di consegnare i rottami ai periti di Varsavia.
Risultano allora più comprensibili quei timori di Palmieri e l’amarezza che lo accompagnò nel resto della vita. Nel 2009 la storica della medicina Luigia Melillo cura per l’Orientale di Napoli con Antonio Di Fiore uno studio sul luminare quasi a riparazione postuma, scoprendo che la sua perizia su Katyn, malgrado la rilevanza internazionale, fu “significativamente” ignorata nell’atto con cui la facoltà di Medicina nel ’75 gli conferiva il titolo di professore emerito. E che nel volume in suo onore, curato da colleghi e allievi, la perizia manca dall’elenco delle 216 pubblicazioni prodotte in carriera. Ne resta unica traccia un articolo che Palmieri redasse nel luglio ’43 per La vita italiana. Perdute poi, perché “misteriosamente bruciate nell’Istituto medico legale di Napoli”, le fotografie scattate dai periti a Katyn, che il professore aveva portato con sé. Prima di lasciarle in Istituto, le aveva nascoste per anni in una scatola avendo cura, a ogni tornata elettorale, di avvolgerla in un impermeabile e interrarla casomai avessero vinto i comunisti.
Il più accanito accusatore di Palmieri fu Eugenio Reale, intimo di Togliatti. Gli studenti comunisti andavano a disturbare le sue lezioni
C’era un clima pesante che nel Dopoguerra fu pesantissimo, come rievocato da Ermanno Rea in Mistero napoletano. “La verità”, gli confidò Maurizio Valenzi, già sindaco ed esponente di spicco del Pci locale, “è che nella follia stalinista ci siamo stati tutti dentro fino al collo, siamo stati tutti nello stesso tempo vittime e persecutori, compiendo azioni e pensando cose che non avremmo voluto mai fare né pensare”. Il più accanito accusatore di Palmieri fu Eugenio Reale, intimo di Togliatti (di cui sarebbe diventato acerrimo nemico dopo i fatti d’Ungheria del ’56). Lo attaccò con più articoli sull’Unità e sulla Voce, esortando il rettore e gli studenti ad allontanare il docente colpevole della “infame missione” di Katyn. Non contento, nel gennaio ’48 Reale segnalò Palmieri a Kostylev, ambasciatore di Stalin a Roma, quale “servo della propaganda di Goebbels” dedito ad attività antisovietiche. L’accanimento produsse qualche effetto: Enzo La Penna, a lungo cronista giudiziario dell’Ansa, rammenta suo zio Pasquale Sica, che si laureò con Palmieri ed esercitò per tutta la vita come medico di base nel rione Arenaccia: “Mi raccontava con rammarico che gli studenti comunisti andavano a disturbare le lezioni del professore e a insultarlo. Ho un aneddoto che spiega quanto quel clima si protrasse. A otto anni andai a vedere a casa di un altro zio, Gigino, militante comunista, la partita Urss-Italia dei Mondiali ’66. Quando telefonò mio padre per sapere il risultato zio Gigino rispose: ‘Abbiamo vinto’. ‘E chi ha segnato?’ chiese papà. ‘Cislenko’”.
Tutto sommato, Palmieri evitò il peggio. Ormai anziano, l’allievo Achille Canfora ne ricordava il “basso profilo”: “Se si fosse esposto disseppellendo il caso Katyn, sarebbe stata a rischio l’incolumità sua e della sua famiglia. Non avevamo dubbi che fosse pedinato”. A proteggerlo furono l’amicizia con De Gasperi e l’appartenenza all’Azione cattolica, che lo portarono per un periodo di nove mesi e 20 giorni, tra il 1962 e il ’63, alla poltrona di sindaco di Napoli, il primo dopo l’epopea di Achille Lauro. Durò poco “perché non si piegava alle pressioni”.
C’era intanto un uomo che voleva disperatamente incontrare Palmieri: Gustaw Herling, lo scrittore polacco reduce dai gulag sovietici che si era stabilito a Napoli sposando Lidia Croce, figlia del filosofo. Herling aveva combattuto a Montecassino con il Corpo del generale Anders e teneva infisso in mente il chiodo di Katyn. Nel ’55 chiese di vedere Palmieri, ma ebbe un secco “no”: si sarebbero conosciuti soltanto nel gennaio ’78. Il professore prese la famosa scatola delle fotografie e gliele mostrò. Centinaia: “Era un cimitero polacco illustrato nel cuore della vecchia Napoli”. Palmieri disse che ancora ricordava il “terribile fetore”, le lettere, le foto di famiglia, i ritagli di giornale nelle tasche dei soldati. “Sembra che siano usciti molti libri su Katyn”, commentò. “Non li ho letti: che cosa possono aggiungere a ciò che conosco per esperienza diretta…”. Dialogavano sommessi come due clandestini.
Gustaw Herling, scrittore polacco reduce dai gulag sovietici, si stabilì a Napoli. Dialogò con Palmieri, sembravano due clandestini
Cosa ancora temevano? Per capirlo aiuta il Breve racconto di me stesso, dove Herling parla del suo trasferimento a Napoli: “Avvertivo chiaramente che mi trovavo in un paese sottoposto alla tutela dei comunisti, e che a mia volta ero oggetto di una continua sorveglianza… Sentivo dunque tutta l’avversione che i comunisti portavano nei miei confronti, e che toccò il suo apice in un articolo pubblicato su Paese Sera, in cui si chiedeva di espellermi dall’Italia”. Per lui, malgrado la parentela illustre, le porte degli intellettuali restarono semichiuse fino alla caduta del Muro: “Solo dopo il 1989, se così si può dire, Napoli si è interessata a me”. Allora finalmente gli presentano il direttore del principale quotidiano cittadino, che gli chiede: “Com’è possibile che lei abita a Napoli da quarant’anni e non sapevamo nulla di lei, ma solo adesso ci conosciamo?”. Herling vorrebbe dire che si sono conosciuti tardi “perché nessuno prima aveva voluto incontrarsi con me”. Decide invece di ribattere con ironia: “Dal momento che i polacchi amano l’attività clandestina, io anche ho vissuto qui in clandestinità”. “Non so”, soggiunge, “se sia stato compreso”. Recita una celebre tarantella ispirata forse dal Buddha, o dal cinismo: “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, / chi ha dato, ha dato, ha dato / Scurdammoce ’o passato…”.
Ma forse è meglio di no.
https://www.simlaweb.it/crimini-guerra-katyn/
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Mario_Palmieri
siti consultati
https://www.quotidianonapoli.it/notizie-in-primo-piano-della-citta-di-napoli-e-della-sua-provincia/e-considerato-un-eroe-in-polonia-quel-medico-napoletano-che-smaschero-la-bugia-di-katyn-due-testimonianze/
Fu un napoletano a inchiodare i sovietici sul massacro di Katyn. I comunisti italiani non l'hanno mai perdonato | Il Foglio
e per finire il foglio di cui riporto integralmente l'articolo
Upon all the living and the dead (J. Joyce)
Il giuramento di Ippocrate vale su tutti i vivi e i morti, anche se i morti non possono guarire né parlare, rimproverare o denunciare. Per non tradire i morti il professor Vincenzo Mario Palmieri, di anni 44, affermato docente napoletano di medicina legale, avrebbe vissuto il mezzo secolo che ancora gli riservò il destino nel timore di essere ucciso, nella denigrazione e in un inesplicabile silenzio. Sperò che tutti dimenticassero di lui ciò che lui non avrebbe mai dimenticato: “Uno spettacolo grandiosamente sinistro, che richiederebbe il verso di Dante o il pennello di Michelangelo”. E che richiese, a Palmieri, un referto scientifico di cui forse si pentì ma non avrebbe ritrattato.
E’ mercoledì 28 aprile 1943 quando il professore, assieme a 12 colleghi di altrettanti paesi, scende dal bus che lo ha portato dalla città russa di Smolensk alla vicina foresta di Katyn, dove le truppe tedesche di occupazione vanno scoprendo un immane massacro. Giacciono accatastati sotto un metro e mezzo di terra sabbiosa, su cui giovani pini e betulle sono stati trapiantati, i corpi di circa ventiduemila militari polacchi perlopiù ufficiali, prigionieri di guerra dei sovietici. Li ha liquidati la polizia segreta Nkvd, secondo un piano che poi si accerterà disposto dal Politburo e curato dal ministro dell’Interno Laurenti Beria. La Germania di Hitler, cui è offerta una formidabile opportunità propagandistica, incolpa della strage i sovietici. La Russia di Stalin respinge l’accusa e attribuisce il crimine ai nazisti. Gli alleati occidentali acconsentono per convenienza alla versione di Mosca. Il governo di Polonia esule a Londra sollecita un’indagine indipendente e il Cremlino, considerando la richiesta un atto ostile, rompe le relazioni diplomatiche con i polacchi. E’ in questo clima che il 23 aprile del ’43 la Croce rossa internazionale apre il Caso Katyn e designa una commissione per stabilire la dinamica del massacro e soprattutto la data: se sia avvenuto prima o dopo l’arrivo dei nazisti.
Per l’ignaro Palmieri la vita sta per cambiare: è stato scelto come rappresentante italiano per caratura accademica e perché parla tre lingue fra cui il tedesco, usato anche in casa con la moglie svizzera Erna Irene von Wattenwyl. Il 24 aprile, Sabato Santo, ha appena comprato la pastiera quando riceve una telefonata che lo invita subito a partire “onde procedere ad un’inchiesta medico-legale sui cadaveri esumati in gran copia nella foresta di Katyn”. La domenica di Pasqua si mette in treno e arriva a Roma, dove viene imbarcato su un aereo per Berlino. Vola martedì 27 via Varsavia a Smolensk con i colleghi, tranne il delegato spagnolo: il professor Piga, racconterà Palmieri, “aveva talmente sofferto nel viaggio in aereo che non riteneva possibile proseguire”. Qualche altro membro della commissione, potendo leggere il futuro, ne avrebbe seguito l’esempio. Come il professor Hayek di Praga. O Markov di Sofia. Quando i rispettivi paesi cadranno sotto influenza sovietica ritireranno le firme dalla perizia, poi finiranno uccisi. Più impressione ancora desterà in Palmieri, nel dopoguerra, la morte misteriosa del generale medico francese Costeodat, che aveva preso parte da osservatore alla commissione.
La perizia conclusiva della Croce rossa, siglata all’unanimità, non lasciava adito a dubbi: lo sterminio ebbe luogo tra marzo e aprile 1940 e si trattò, scrisse Palmieri, “di un’esecuzione sistematica, realizzata da persone particolarmente esperte”. Gli esami medici, botanici, balistici, coincidenti con le testimonianze raccolte fra la popolazione, trovavano conferma nelle carte rinvenute sui corpi, riferibili a un’epoca compresa tra l’autunno ’39 e l’aprile successivo. La maggioranza delle salme fu identificata facilmente perché i militari, caricati a gruppi sui camion dai campi di prigionia al luogo dell’esecuzione, vestivano la propria uniforme invernale e conservavano portafogli e documenti personali.
E’ mercoledì 28 aprile 1943. Vincenzo Mario Palmieri scende dal bus che lo ha portato dove i tedeschi hanno scoperto un immane massacro
Alla riconquista del territorio, il Cremlino nominerà la commissione medica Burdenko sotto suo diretto controllo, che sosterrà la matrice nazista dell’eccidio con un’opera di manipolazione dagli effetti duraturi, anche se nel mondo occidentale le reticenze cadono e nel 1951 un’inchiesta promossa dal Congresso americano accerta l’esistenza di “prove definitive e inequivocabili” contro i sovietici. Bisognerà aspettare la caduta del Muro di Berlino perché a Mosca ammettano le responsabilità: solo nel 1990 Gorbaciov porge le scuse ufficiali alla Polonia e nel ’92 Eltsin desecreta parte degli archivi tra cui i documenti su Katyn. Magari il professor Palmieri, che muore il 23 dicembre del ’94 ancora lucido malgrado un ictus sofferto anni prima, avrà guardato con sollievo a questa conclusione. Se lo fece, s’illuse. Perché non era (non è) finita. Nel 2004 Putin impone nuovamente il segreto di stato sulle carte, che sono un tassello dei complessi rapporti tra la Russia e la Polonia, e quando poi deplorerà l’eccidio ne parlerà come di un crimine stalinista (prima di rivalutare Stalin stesso).
Ma ormai nell’Italia degli anni Duemila nessuno si ricorda più dell’uomo che stese di suo pugno il primo referto su Katyn, lavorando su quel testo con i colleghi fino all’alba. Nessuno si ricorda o quasi: il 10 ottobre 2004, rispondendo a un lettore sul Corriere della Sera, Paolo Mieli ripercorre la vicenda e osserva che “i sovietici si impegnarono a screditare chiunque avesse collaborato con quella commissione”. Cita un’opera fondamentale, Il massacro di Katyn di Victor Zaslavsky, in cui si riferiva “dell’intimidazione e della denigrazione comunista nei confronti del professore napoletano Vincenzo Mario Palmieri che si era occupato del caso. E che, per essersi avvicinato alla verità e averne parlato pubblicamente, fu definito dal Pci ‘collaborazionista’, ‘fascista’, ‘nazista’, ‘servo della propaganda di Goebbels’, ‘menzognero e falsificatore della verità storica’. Una storia molto triste”.
Bisogna aspettare la caduta del Muro perché a Mosca ammettano le responsabilità. Nel 2004 Putin impone di nuovo il segreto di stato sulle carte
Molto triste sì ma adesso, aprile 2022, sembra tutto lontano: è lontano il luglio del ’43, quando il generale polacco Wladyslaw Sikorski, che ha chiesto conto a Stalin dell’eccidio, muore in un misterioso incidente aereo. Lontano il marzo ’46, quando il procuratore di Cracovia Roman Martini, che indaga su Katyn, viene ucciso sotto casa. Lontano persino il 10 aprile 2010, quando il presidente della Repubblica polacca, Lech Kaczynski, perisce con altre 95 persone (tra cui i membri dello stato maggiore) mentre vola a Smolensk per commemorare le vittime. Ma lontano molto meno è maggio 2020, quando vengono rimosse le targhe che ricordavano la strage dall’ex edificio dell’Nkvd, alla vigilia del settantacinquesimo anniversario della vittoria sul nazismo. E lontana per nulla, bensì di questi giorni, è la conclusione della commissione d’inchiesta polacca sulla fine di Kaczynski, che ribaltando le precedenti indagini non attribuisce il disastro a errori umani ma a due esplosioni sul Tupolev presidenziale, di cui i russi si sono sempre rifiutati di consegnare i rottami ai periti di Varsavia.
Risultano allora più comprensibili quei timori di Palmieri e l’amarezza che lo accompagnò nel resto della vita. Nel 2009 la storica della medicina Luigia Melillo cura per l’Orientale di Napoli con Antonio Di Fiore uno studio sul luminare quasi a riparazione postuma, scoprendo che la sua perizia su Katyn, malgrado la rilevanza internazionale, fu “significativamente” ignorata nell’atto con cui la facoltà di Medicina nel ’75 gli conferiva il titolo di professore emerito. E che nel volume in suo onore, curato da colleghi e allievi, la perizia manca dall’elenco delle 216 pubblicazioni prodotte in carriera. Ne resta unica traccia un articolo che Palmieri redasse nel luglio ’43 per La vita italiana. Perdute poi, perché “misteriosamente bruciate nell’Istituto medico legale di Napoli”, le fotografie scattate dai periti a Katyn, che il professore aveva portato con sé. Prima di lasciarle in Istituto, le aveva nascoste per anni in una scatola avendo cura, a ogni tornata elettorale, di avvolgerla in un impermeabile e interrarla casomai avessero vinto i comunisti.
Il più accanito accusatore di Palmieri fu Eugenio Reale, intimo di Togliatti. Gli studenti comunisti andavano a disturbare le sue lezioni
C’era un clima pesante che nel Dopoguerra fu pesantissimo, come rievocato da Ermanno Rea in Mistero napoletano. “La verità”, gli confidò Maurizio Valenzi, già sindaco ed esponente di spicco del Pci locale, “è che nella follia stalinista ci siamo stati tutti dentro fino al collo, siamo stati tutti nello stesso tempo vittime e persecutori, compiendo azioni e pensando cose che non avremmo voluto mai fare né pensare”. Il più accanito accusatore di Palmieri fu Eugenio Reale, intimo di Togliatti (di cui sarebbe diventato acerrimo nemico dopo i fatti d’Ungheria del ’56). Lo attaccò con più articoli sull’Unità e sulla Voce, esortando il rettore e gli studenti ad allontanare il docente colpevole della “infame missione” di Katyn. Non contento, nel gennaio ’48 Reale segnalò Palmieri a Kostylev, ambasciatore di Stalin a Roma, quale “servo della propaganda di Goebbels” dedito ad attività antisovietiche. L’accanimento produsse qualche effetto: Enzo La Penna, a lungo cronista giudiziario dell’Ansa, rammenta suo zio Pasquale Sica, che si laureò con Palmieri ed esercitò per tutta la vita come medico di base nel rione Arenaccia: “Mi raccontava con rammarico che gli studenti comunisti andavano a disturbare le lezioni del professore e a insultarlo. Ho un aneddoto che spiega quanto quel clima si protrasse. A otto anni andai a vedere a casa di un altro zio, Gigino, militante comunista, la partita Urss-Italia dei Mondiali ’66. Quando telefonò mio padre per sapere il risultato zio Gigino rispose: ‘Abbiamo vinto’. ‘E chi ha segnato?’ chiese papà. ‘Cislenko’”.
Tutto sommato, Palmieri evitò il peggio. Ormai anziano, l’allievo Achille Canfora ne ricordava il “basso profilo”: “Se si fosse esposto disseppellendo il caso Katyn, sarebbe stata a rischio l’incolumità sua e della sua famiglia. Non avevamo dubbi che fosse pedinato”. A proteggerlo furono l’amicizia con De Gasperi e l’appartenenza all’Azione cattolica, che lo portarono per un periodo di nove mesi e 20 giorni, tra il 1962 e il ’63, alla poltrona di sindaco di Napoli, il primo dopo l’epopea di Achille Lauro. Durò poco “perché non si piegava alle pressioni”.
C’era intanto un uomo che voleva disperatamente incontrare Palmieri: Gustaw Herling, lo scrittore polacco reduce dai gulag sovietici che si era stabilito a Napoli sposando Lidia Croce, figlia del filosofo. Herling aveva combattuto a Montecassino con il Corpo del generale Anders e teneva infisso in mente il chiodo di Katyn. Nel ’55 chiese di vedere Palmieri, ma ebbe un secco “no”: si sarebbero conosciuti soltanto nel gennaio ’78. Il professore prese la famosa scatola delle fotografie e gliele mostrò. Centinaia: “Era un cimitero polacco illustrato nel cuore della vecchia Napoli”. Palmieri disse che ancora ricordava il “terribile fetore”, le lettere, le foto di famiglia, i ritagli di giornale nelle tasche dei soldati. “Sembra che siano usciti molti libri su Katyn”, commentò. “Non li ho letti: che cosa possono aggiungere a ciò che conosco per esperienza diretta…”. Dialogavano sommessi come due clandestini.
Gustaw Herling, scrittore polacco reduce dai gulag sovietici, si stabilì a Napoli. Dialogò con Palmieri, sembravano due clandestini
Cosa ancora temevano? Per capirlo aiuta il Breve racconto di me stesso, dove Herling parla del suo trasferimento a Napoli: “Avvertivo chiaramente che mi trovavo in un paese sottoposto alla tutela dei comunisti, e che a mia volta ero oggetto di una continua sorveglianza… Sentivo dunque tutta l’avversione che i comunisti portavano nei miei confronti, e che toccò il suo apice in un articolo pubblicato su Paese Sera, in cui si chiedeva di espellermi dall’Italia”. Per lui, malgrado la parentela illustre, le porte degli intellettuali restarono semichiuse fino alla caduta del Muro: “Solo dopo il 1989, se così si può dire, Napoli si è interessata a me”. Allora finalmente gli presentano il direttore del principale quotidiano cittadino, che gli chiede: “Com’è possibile che lei abita a Napoli da quarant’anni e non sapevamo nulla di lei, ma solo adesso ci conosciamo?”. Herling vorrebbe dire che si sono conosciuti tardi “perché nessuno prima aveva voluto incontrarsi con me”. Decide invece di ribattere con ironia: “Dal momento che i polacchi amano l’attività clandestina, io anche ho vissuto qui in clandestinità”. “Non so”, soggiunge, “se sia stato compreso”. Recita una celebre tarantella ispirata forse dal Buddha, o dal cinismo: “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, / chi ha dato, ha dato, ha dato / Scurdammoce ’o passato…”.
Ma forse è meglio di no.