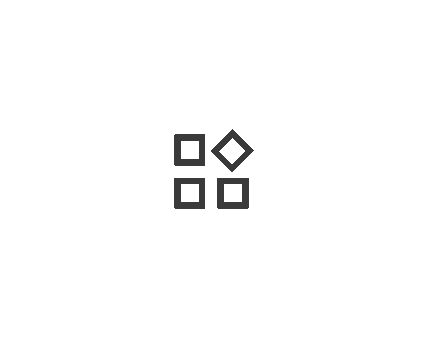Questo ragazzo si chiama Dario Costa, è un siciliano di 21 anni, ed è appena stato sottoposto a una vergognosa gogna nientemeno che dal Vicpresidente del Consiglio Matteo Salvini.
Tutto per cinque secondi di video, tagliati e decontestualizzati da un video molto più lungo, nei quali Dario ha definito il Ponte sullo Stretto “un atto delinquenziale”.
Una frase dura, certo, ma che affonda in un passato purtroppo esistente e per nulla campata per aria. Anzi.
Eppure tanto è bastato perché Salvini

trasformasse quei cinque secondi in un video di scherno indegno, con tanto di montaggio al rallentatore derisorio, trasformando all’istante Dario nel bersaglio di migliaia di odiatori, che in poche ore gli hanno tirato addosso di tutto: insulti, offese, addirittura minacce di morte.
Siamo al punto che un ministro dei Trasporti di 50 anni bullizza stavolta direttamente senza cani da guardia un libero cittadino di 20\ anni - non iscritto a nessuna associazione o partito - solo per aver espresso una critica (comprensibile) sul Ponte sullo Stretto.
Questa è l’idea di libertà e di democrazia di Matteo Salvini.
Così povero di argomentazioni da essere costretto a fare il bullo con un ragazzo che protesta.
Ma ha trovato qualcuno che nn piega la testa e ha pronta la risposta . Dario Costa – questo il nome del 21enne di Messina protagonista della clip – ha risposto al ministro con un video che trovate sotto
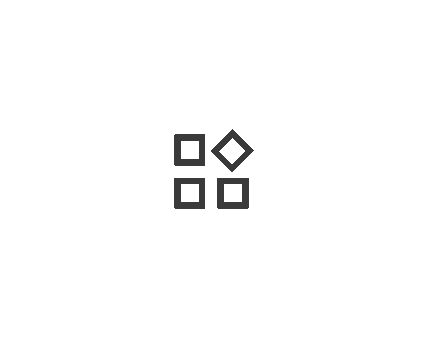
su TikTok: «Caro Salvini, lei non è un ministro ma un uomo cui è stato dato troppo potere – dice – Mi hanno augurato morte, infarto, castrazione chimica, tumori e minacciato di pestaggio». Costa ha dichiarato che denuncerà alla polizia postale gli autori degli insulti social. «Ha fatto tutto questo – dice nell’ultima sferzata al ministro – perché ha paura del dissenso»