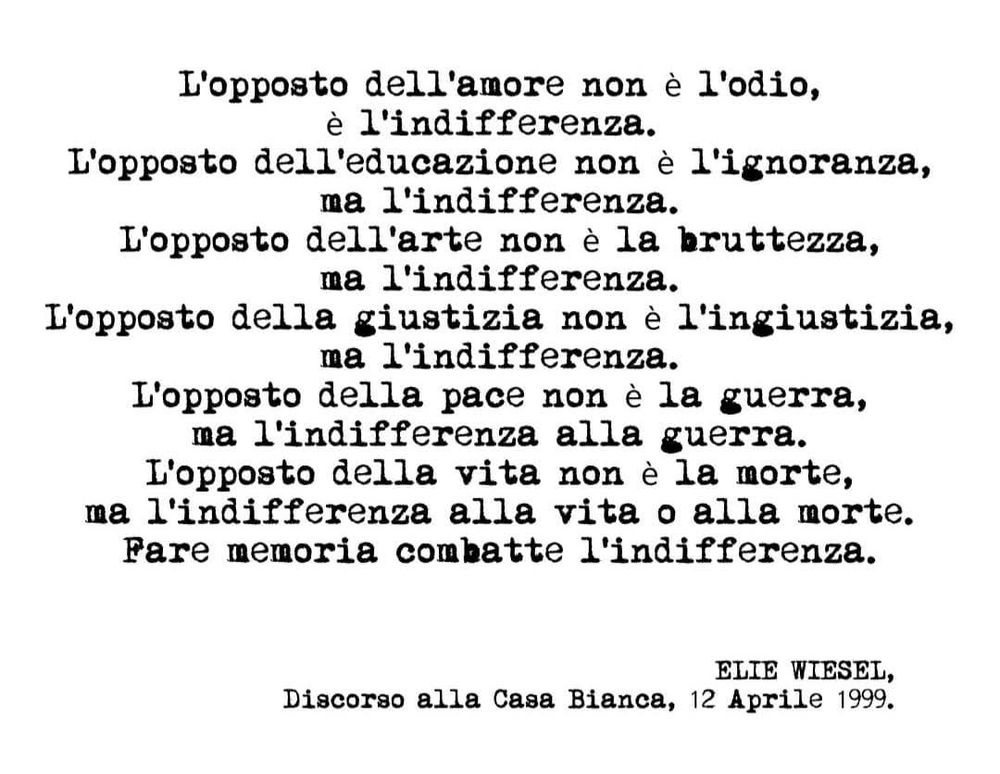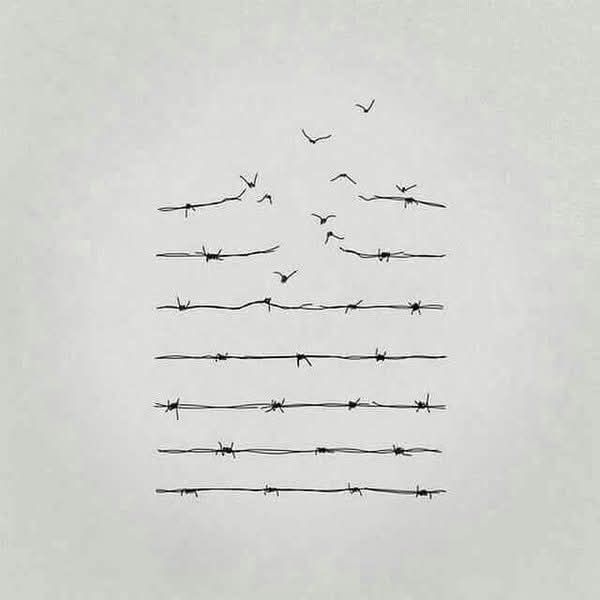Davide Bonazzi
Condividi
Stampa
Kazimierz è il quartiere ebraico di Cracovia, nel sud della Polonia. Qualcuno lo conoscerà per Schindler’s list, che è stato girato qui. I resti di un finto campo di concentramento, costruito per il film, sono conservati in una cava di pietra calcarea qui vicino. Le persone ci vanno e girano film in cui fissano pezzi di filo spinato.
Di questi tempi va di moda dire “Mai più per nessuno”. È una variante del giuramento “Mai più”, che fu pronunciato per la prima volta dai detenuti liberati a Buchenwald e più tardi dal rabbino di estrema destra Meir Kahane. Non sono sicura che da queste parti la gente si dedichi molto ai princìpi del “Mai più”. Per lo più è impegnata a mangiare. Sono davanti al ristorante Ariel, sulla piazza. Il ristorante suona musica ebraica, serve piatti ebraici ed è arredato come una vecchia casa ebraica, con le pareti verdi, i pavimenti di legno e un candeliere.
I monumenti alla memoria dell’Olocausto sono diffusi quanto l’odio per gli ebrei, e per questo ho la vaga idea che siano fondamentalmente sbagliati
Su una mensola c’è la statuina di un ebreo. Sarà alta dieci centimetri e ha in mano una grossa moneta: riportata alla sua scala, avrebbe le dimensioni di un sombrero. È l’Ebreo fortunato, un talismano che secondo i polacchi porta ricchezza. A Cracovia potete comprare un Ebreo fortunato o, se preferite, un draghetto. Sono ugualmente leggendari. A me non dispiacciono. Nel 1939 in Polonia c’erano 3,3 milioni di ebrei e oggi ce ne sono appena 4.500; il rabbino capo della Polonia è statunitense e questa è una specie di resa. Per arrivare ai numeri precedenti alla guerra bisognerebbe contare tra gli ebrei polacchi anche le statuine giocattolo. Essere un pupazzo è una specie di destino: nulla è più docile e disposto ad accettare la propria sorte.
Alle pareti sono appesi diciannove quadri di ebrei che contano i soldi, e questo è un ristorante frequentato dalla gente che pensa di amare gli ebrei. Ci sono anche un paio di cavalli dall’aria beata come la vergine Maria, se fosse un cavallo. Gli ebrei, invece, sono irsuti e demoniaci, impegnati a contare banconote o monete, anche se ce n’è uno che esamina un uovo. Mangio qui spesso, a volte da sola, e una volta con una donna che avevo incontrato mentre piangeva fuori della sinagoga il venerdì sera. La funzione era stata annullata perché non c’era il minian: servono dieci persone per celebrare una funzione, e non c’erano.
Dico “shalom” a un gruppo di uomini tedeschi a voce troppo alta. Sembrano dei vichinghi. Non dico tanto per dire. Rispondono con un silenzio talmente profondo che è praticamente un rumore. A quanto pare non vogliono parlare con un’ebrea in carne e ossa in un locale a tema ebraico. È come se il vero Paperino si presentasse a Disneyland, mentre loro vogliono solo quello della loro fantasia. Cerco di essere un’ebrea interessante. Quando la banda suona musica ebraica, canto e batto le mani sul tavolo. Sono un’attrazione turistica, così mi filmano.
Sono un’ebrea britannica, e mi hanno insegnato che il vero mondo ebraico è qui. Peccato che non sia vero. La famiglia di mia nonna è di Łódz, circa duecentocinquanta chilometri a nordovest. Ha vissuto con disagio nel Regno Unito, un paese che non le apparteneva. Quando ero bambina, mi ricordo che cantava di un bambino affogato nella vasca da bagno. Forse sono così anch’io. Anch’io sono a disagio. L’antisemitismo è dilagato, ma c’è una contraddizione che m’interessa: la proliferazione di monumenti alla memoria dell’Olocausto.
Nel Regno Unito, il governo vuole farne costruire uno immenso vicino al parlamento, anche se il paese non si è macchiato di nessuna complicità se non quella di aver impedito agli ebrei di fuggire in Palestina. Il progetto sembra lo scheletro di un dinosauro, o la griglia di un tostapane, e se ha qualcosa a che fare con il popolo ebraico, non so dire cosa sia. Piuttosto, sembra inconsciamente collegato ai crimini dell’imperialismo britannico, che vengono citati più raramente nel dibattito pubblico. Mi chiedo se il monumento sia uno specchio in cui vediamo solo il nostro riflesso così da non dover guardare il passato.
Due dei libri più venduti sulla Shoah sono Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne, che non parla di un ebreo, e il Diario di Anne Frank, che non parla della Shoah. La zona d’interesse parla della Shoah, ma spogliata degli ebrei. In realtà, il film parla dell’estetica dei campi di concentramento e di beni di consumo.
I monumenti alla memoria dell’Olocausto sono diffusi quanto l’odio per gli ebrei, e per questo ho la sensazione che siano fondamentalmente sbagliati.
Dagli anni novanta, dopo la caduta del muro di Berlino, in Polonia c’è stato un rinascimento ebraico. A Kazimierz ci sono un centro sociale ebraico, un centro per la cultura ebraica, un festival della cultura ebraica e una piccola comunità ebraica. Gli ortodossi, custodi designati delle sinagoghe e dei cimiteri, non ammettono nella loro comunità ebrei nati fuori della Polonia, anche se accolgono i visitatori ortodossi, compresi gli israeliani. Mi aggrego a loro nella sinagoga di Remuh, sulla piazza. Per un’ora raddoppiano la popolazione ebraica di Cracovia.
Il centro sociale ebraico ammette chi ha almeno un nonno ebreo – la Polonia è piena di ebrei inconsapevoli, parziali o appena risvegliati – e ha perfino un asilo per l’infanzia. Poi c’è Chabad, che accoglie tutti gli ebrei (a patto che siano maschi). Sono stata alla sinagoga di Chabad ma me ne sono andata quando mi hanno invitata a sedermi in un corridoio lungo un muro spoglio. Si può amare un mondo ebraico perduto, ma non si è sempre ricambiati. Il mio compagno è più fortunato. Lui non siede nell’atrio. Compra un barattolo di sottaceti, che si porterà dietro per tutta la Polonia come un talismano.
Ci sono stati più salvatori (i Giusti) in Polonia che in qualsiasi altra parte del mondo, ma ci sono stati anche collaborazionisti e assassini. Il 10 luglio 1941, prima che il paese di Jedwabne fosse occupato, gli uomini del villaggio rinchiusero i loro vicini ebrei in un fienile e lo incendiarono; un monumento eretto nel 1963 ha dato la colpa ai tedeschi. Nel 2001, la pubblicazione di I carnefici della porta accanto di Jan T. Gross (Mondadori 2002), una ricostruzione del massacro di Jedwabne, ha offeso l’amor proprio della Polonia. Quello stesso anno, il presidente polacco Aleksander Kwaśniewski si è scusato per l’accaduto. L’attuale presidente, Andrzej Duda, ha invece definito questa sorta di penitenza “un tentativo di distruggere il buon nome della Polonia”. Il partito di destra Diritto e giustizia, che è andato al potere nel 2015, ha scatenato una campagna contro gli storici e i direttori dei musei non allineati alla narrazione del martirio polacco, e nel 2018 ha approvato una legge che vieta di accusare i polacchi o la Polonia dei crimini commessi dai tedeschi. Di questi tempi, solo un accademico polacco particolarmente coraggioso si azzarderebbe a parlare del pogrom di Kielce del 1946, in cui furono uccisi quarantadue superstiti ebrei. Nel 2023, però, Diritto e giustizia ha perso la maggioranza, e il nuovo governo guidato dal primo ministro centrista Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo e già primo ministro dal 2007 al 2014, ha poco tempo da perdere per le dispute sulla memoria.
Ho appuntamento con Jakub Nowakowski al Museo ebraico della Galizia. È un cattolico nato a Kazimierz. Sua madre parlava qualche parola di yiddish e di ebraico che aveva imparato a sua volta da sua madre, che da bambina aveva dei vicini di casa ebrei. Ha saputo da dove venivano solo anni dopo. “Ci siamo molto impegnati a riscrivere la storia che avevamo inventato”, dice Nowakowski, “non solo quella dei Giusti ma anche quella degli ebrei che sono stati traditi. E ci siamo spinti così avanti che abbiamo creato parecchia confusione”.
“Chi è il più famoso dei Giusti?”, mi chiede. Oskar Schindler? “Schindler”, ripete. “È una follia, ma il Giusto più famoso è un maledetto tedesco. Ci sono migliaia di Giusti polacchi che hanno rischiato molto di più e in una situazione ben più terribile”. Gli Ulma di Markowa – Józef, Wiktoria e i loro sei figli – furono sorpresi a nascondere degli ebrei nel 1944. Probabilmente furono traditi da un polacco, e furono fucilati. Il Museo della famiglia Ulma sui polacchi che hanno salvato gli ebrei (dagli altri polacchi) durante la seconda guerra mondiale è stato aperto nel 2016.
Il trauma della Polonia a volte si trasforma in qualcosa che sembra un film di Mel Brooks. Una volta Nowakowski è stato avvicinato da un uomo che diceva di essere originario della città con l’unica sinagoga superstite nella regione del Podhale. “Mi dice: ‘Faremo un museo dei Giusti del nostro villaggio’. Gli rispondo: ‘Splendida idea! Quanti ce n’erano nel suo villaggio?’.
‘Lo vuole sapere?’, mi fa. ‘Zero! E quanti ce n’erano nel villaggio più vicino?’. Fa una pausa poi dice: ‘Uno!’”.
Faccio un giro del ghetto. Incontro una guida, un tipo snello e gentile. Mi mostra un monumento in memoria della liquidazione del ghetto, che consiste in una serie di sedie vuote: un macabro negozio di mobili. “Ci sono due nazioni o due religioni che vivono in una sola casa”, dice, “o un tempo vivevano in una sola casa, e soprattutto si considerano tutte e due nazioni elette”. Si mette a ridere: “Gli ebrei, che sono il popolo eletto, e i polacchi, che hanno questa idea nazionalista di essere il Gesù dei popoli perché hanno sempre sofferto. ‘Noi siamo più eletti!’. ‘No, noi abbiamo sofferto di più!’”. Ho sempre pensato che la mia capacità di soffrire fosse una peculiarità ebraica. Adesso penso che sia una peculiarità ebraico-polacca, e per la prima volta da quando sono qui mi sento a casa, insieme ai sofferenti.
Incontro Janusz Makuch al café Cheder: è un uomo cordiale e impetuoso. Ha fondato il festival della cultura ebraica nel 1988. Mi dice che al partito Diritto e giustizia piaceva molto costruire monumenti e musei. “Gli piaceva tanto enfatizzare i Giusti. I polacchi hanno salvato milioni di ebrei!”, dice con una vocina sciocca. “I polacchi, i polacchi, il popolo Giusto… capisci cosa intendo?”.
Gli chiedo: cosa c’è che non va nell’onorare la memoria della Shoah? Rimane in silenzio per un bel po’. “Non ci vedo la verità”, dice alla fine. “La gente non vuole conoscere la verità”. Ha ragione. L’ebreo del Bambino con il pigiama a righe, la favola di Boyne su Auschwitz, sembra più un Cristo bambino che un qualsiasi bambino ebreo che mi sia capitato di incontrare: dov’è la sua ansia? La zona d’interesse sceglie un’estetica senza gli ebrei. A volte il museo statale di Auschwitz-Birkenau sconsiglia di adottare alcune opere nelle scuole: il libro di Boyne, per esempio. Boyne ha detto che cerca di mantenere la Shoah nella coscienza pubblica, come se fosse un marchio che non può sopravvivere senza il suo aiuto.
“Possiamo sforzarci quanto vogliamo”, dice alla fine Makuch. “Possiamo provare a ricostruire il nostro mondo in Polonia. L’abbiamo fatto. Auguro tutto il meglio alla gente che vive qui e vuole costruire un futuro ebraico e ricreare una società ebraica. L’abbiamo fatto. Abbiamo i musicisti klezmer, abbiamo i ristoranti ebraici, abbiamo i camerieri con la kippah. Stronzate. Più ne abbiamo, più dolorosamente ci rendiamo conto che viviamo nell’assenza”.
Dice: “Arriviamo, costruiamo qualcosa, organizziamo la mostra al museo e la nostra coscienza, il nostro senso di colpa, sono a posto. Abbiamo fatto qualcosa”. Poi fa una pausa e sussurra, furioso. “No. Non abbiamo fatto niente! E i nostri figli, il nostro sistema scolastico? La nostra chiesa?”. La chiesa cattolica ha assolto gli ebrei per l’assassinio di Cristo, il mito fondativo dell’odio per gli ebrei, solo nel 1965. “E i polacchi che vivono ancora nelle case degli ebrei?”.
Continua: “Questa è la narrazione ufficiale polacca: abbiamo vissuto insieme quasi mille anni”. Sussurra, feroce: “Non abbiamo mai vissuto insieme, stronzi che non siete altro. Abbiamo vissuto fianco a fianco. Gli ebrei non si curavano dei polacchi. I polacchi non si curavano degli ebrei. Ogni antisemita ha il suo ebreo a cui vuole bene. Tutti gli altri alle camere a gas”. Prima che mi congedi, mi dà un consiglio: “Non cercare di generalizzare, non cercare una chiave sola per capire. È troppo complicato. Ci sono un sacco di porte in questo shtetl che è la Polonia”.

Davide Bonazzi
La mattina dopo fermo un golf cart con la scritta “ghetto”. Alla guida c’è un britannico di nome Alex. Dice che posso fargli delle domande sul suo lavoro di guida turistica se gli do cinquanta euro. “Gli ebrei controllavano tutto”, dice ai turisti che gli chiedono il perché dello sterminio. “Avevano tutte le attività imprenditoriali, ma avevano lavorato per averle, nessuno gliele aveva regalate”. Se controllavano tutto, rispondo, non sarebbe stato complicato ammazzarli? “Non tutto”, ammette, “ma economicamente… Si erano collocati più in alto della gente del posto, e questo ha fatto saltare i nervi a un sacco di persone. Sto solo esponendo le diverse motivazioni, non sono necessariamente d’accordo”.
Un tempo faceva la guida ad Auschwitz. “Mi piaceva lavorare lì. Mi piacevano i clienti. Facevo mettere i visitatori dietro il recinto e dicevo, ‘Avete visto il film Il bambino con il pigiama a righe? Ecco, è la stessa cosa’. Nelle mie visite guidate faccio tutto, comprese le cose che i miei colleghi non fanno, cioè anche abbattere le barriere, certo, in modo che la gente capisca veramente”, dice allegramente. “Capiscono le cose da angolazioni diverse, da entrambe le parti, non solo dal punto di vista degli ebrei, anche loro non sono troppo carini”.
“Alcune persone volevano vedere la scena”, spiega. “Allora io afferravo una donna per le spalle e dicevo: ‘Immaginate se vostra moglie fosse presa in questo modo e buttata lì da una parte’. A volte facevo mettere le persone in fila e dicevo: ‘Benvenuti ad Auschwitz. Toglietevi i vestiti’”.
“Cracovia è un bel posto”, dice, “ma se non ci fosse Auschwitz, non sarebbe un’attrazione così grande”. Cos’hai imparato sugli ebrei da quando sei qui? Si mette a ridere. “Che non sono veramente i benvenuti. Ah ah!”. Perché la gente va ad Auschwitz? “Si divertono! Il problema”, continua, “è che si è trasformata in una vacanza, come a EuroDisney”. È questo che ti dà fastidio? “Ha distrutto l’atmosfera di come dovrebbe essere. La macchina del turismo ha ucciso Auschwitz”. Ha l’aria affranta. Mi capita spesso di pensare ad Alex. E spesso penso che ha ragione.
Il campo di concentramento e sterminio Auschwitz-Birkenau si trova vicino alla cittadina di Oświęcim, in corrispondenza di due diverse intersezioni: quella delle linee ferroviarie transeuropee e quella dei fiumi Soła e Vistola. Gli ebrei arrivavano in treno e se ne andavano lungo i fiumi, che sfociano nel mar Baltico. Auschwitz è il nome tedesco di Oświęcim. Dopo la guerra, i tedeschi se ne sono andati e sono arrivati i sovietici. I polacchi hanno deciso che il campo di sterminio dovesse conservare il suo nome tedesco, e mi sembra giusto.
Per scrivere questo articolo vado due volte ad Auschwitz. La prima volta prendo un autobus turistico da Cracovia. La seconda prendo il treno.
Incontro un tassista alla stazione. “Tutto il mondo la conosce come un campo di concentramento”, dice, “e non sa che è una bellissima città. I bus turistici portano la gente direttamente da Cracovia a qui. Non si fermano al castello. Vivo a cinque minuti da qui, c’è una cascata”. Il giorno dopo, quando salgo su un taxi e dico “campo di sterminio”, l’autista sospira e ripete, non in tono scortese, “campo di sterminio”. Il giorno dopo ancora, quando monto in taxi e dico “campo di sterminio”, come se recitassi e la mia unica battuta fosse “campo di sterminio”, il tassista mi guarda con il volto segnato dalla preoccupazione. Poi mi prega di andare a visitare un parco a tema di nome Energylandia, che ha due montagne russe. La squadra di Oświęcim è anche molto forte nell’hockey su ghiaccio. Non importa niente a nessuno.
La città si sviluppa attorno un’antica piazza con delle fontane che di sera s’illuminano di viola. Più in là c’è un centro commerciale patinato con un Kfc e un McDonald’s, tranquillizzante nella sua somiglianza con ogni altro McDonald’s. D’estate sembra oziosa, come se mancasse qualcosa. In tutta la Polonia è come se mancasse qualcosa, come se il paese fosse sbocciato da una grande sofferenza sepolta.
Facciamo una passeggiata. Via Berka Joselewicza – la vecchia via ebraica – è deserta: al posto della grande sinagoga adesso c’è un parco dall’atmosfera tetra. Il primo cimitero ebraico, fondato nel 1588, è scomparso. Nessuno sa dove sia, anche se a volte qualcuno ristruttura la casa e trova delle lapidi nelle pareti e sotto i pavimenti. Alla fine troviamo l’ebreo del posto. È una statuina alta quindici centimetri ed è esposta nella vetrina di un negozio. Forse è questa la logica conclusione della storia degli ebrei in Europa: un pupazzetto di quindici centimetri che controlla un mondo di quindici centimetri. Il proprietario mi saluta da dietro il vetro. Non ce la faccio a entrare e a chiedere quanto costa l’ebreo in vetrina. Lo risaluto. Troviamo un murale con un ritratto di papa Giovanni Paolo II vicino a una gelateria. Ha l’espressione neutra. Dalla sua bocca esce un fumetto che dice: “Antysemityzm jest grzechem przeciw bogu i ludzkosci” (l’antisemitismo è un peccato contro Dio e l’umanità). Troviamo il Museo del castello con i suoi tableaux della vita anteguerra e la sua collezione di attrezzature sportive prebelliche, tra cui mazze da hockey, stoviglie e bambole inquietanti.
Quando chiedo di vedere qualcosa sulla vita ebraica, mi indirizzano al Museo ebraico Oshpitzin quasi con aria sollevata, anche se mi fermo abbastanza alla loro mostra sull’hockey su ghiaccio per segnare un gol, cosa che mi dà grande soddisfazione. Il museo ebraico è adiacente a una piccola sinagoga ristrutturata con i fondi della diaspora. Non ho mai visto una sinagoga così immacolata, ma manca la congregazione: sembra un teatro da dove gli attori se ne sono andati. Accanto c’è la casa dell’ultimo ebreo di Oświęcim, Szymon Kluger, morto nel 2000. In suo onore, adesso è stata trasformata in un caffè per hipster: legno chiaro, giochi da tavolo, tè esotici, spille con la scritta “coexist”. Mangio lentamente un bagel e penso: non è un po’ troppo tardi?

Davide Bonazzi
Al museo incontro Artur, un uomo dall’aria solenne e studiosa. È cresciuto a Oświęcim e dice che all’epoca la storia locale era “vuota, come una pagina bianca. Sono sicuro che molta gente non vuole parlarne, vuole dimenticare. Un piccolo gruppo di persone ha provato a ravvivare la comunità, ma ora se ne sono andati tutti. Hanno abbandonato la città, soprattutto a causa dell’antisemitismo”. Mi porta nella sinagoga e mi mostra una torah. Ce ne sono due, donate dai gruppi ebraici statunitensi: troppa grazia. Chiedo se posso baciare il bordo della copertina, e mi dà il permesso. È un incontro talmente imbarazzato che potremmo essere entrambi inglesi.
Fuori ci sono due giovani uomini che prendono il sole sulle sedie a sdraio. Uno è tedesco, l’altro è cresciuto qui. Se n’è andato quando aveva diciassette anni. Quando gli chiedo perché è venuto qui, al museo ebraico, dice: “Questo è un posto superinternazionale”. Penso che non sappia spiegare cosa lo spinge qui, ma mi racconta dei tempi in cui andava a scuola. “Un giorno ho chiesto del campo e mi hanno risposto: ‘È vietato parlarne. È come il nome di Voldemort in Harry Potter’”. Nel cortile della scuola dare dell’ebreo a qualcuno era un insulto. “Mi ricordo che te lo dicevano se rubavi le sigarette o se sembravi sporco. Ce lo dicevamo a vicenda senza nemmeno sapere che cosa significava. Magari chiedevi una penna e qualcuno non te la dava e ti diceva: ‘Ebreo di merda’”.
Passo ore seduta alla pizzeria Da Grasso nella piazza della città. Un tempo era una casa di proprietà di ebrei – l’hotel Herz – e Barbara Leibler, una discendente dell’ex proprietario, ha presentato una petizione al governo perché le sia restituita. Dubito che ci riuscirà: nel 2021 il termine ultimo per fare appello alle ordinanze di restituzione è stato fissato a trent’anni. Me ne sto seduta a mangiare spaghetti al pomodoro, guardando la piazza come se fosse una foto a doppia esposizione. Gli ebrei si radunavano qui per le deportazioni. Nonostante questo, Oświęcim è il mio posto preferito in Polonia. Non cerca di essere qualcosa che non è. È onesta.
So com’è fatto Auschwitz perché ho visto X-Men – Apocalisse, del 2016, che è parzialmente ambientato qui. Ma non sono preparata alla sua apparente normalità. Gli edifici sono di mattoni rossi, disposti come un mazzo di carte. È stato detto che qui gli uccelli non cantano, ma è una leggenda: fanno un sacco di rumore, sono indaffarati con i pulcini. Ho registrato un video, vorrei farvelo vedere. Sembra troppo banale per essere quello che è, ma è un condizionamento: non è reale, non può esserlo. È luminoso e ventoso.
Jerzy Putrament, un comunista, fece una profezia nel 1948, quando il museo di Auschwitz era aperto da un anno. “Mi immagino tour di americani tipo quelli organizzati dall’agenzia Cook”, scrisse. “Conoscete il più grande centro di sterminio del mondo? Preparatevi a incontrare l’inferno!”. Quei tour sarebbero stati divisi in normali, turistici e speciali. Quelli speciali, per un sovrapprezzo adeguato, avrebbero compreso quanto segue: trasporto al campo in vagoni merci (gli ultimi dieci chilometri) con 120 persone per ogni vagone, e una marcia forzata guidata da uomini delle Ss in uniforme muniti di manganelli. Alex, il mio autista a Cracovia, è la guida turistica di Putrament venuta dal futuro, o almeno ci ha provato.
Putrament apprezzerebbe le recensioni da una stella di Auschwitz su Tripadvisor, da cui sono un po’ ossessionata. Ci sono molte lamentele, non sulla sua esistenza ma sulla logistica. “Ero così impaziente di fare questa visita”, scrive Mike da Pocklington. “Che delusione… Zero atmosfera… Mi dispiace ma molto deludente”. “Terribile perdita di tempo!”, scrive Piotr da Varsavia, che si lamenta della fila. “Credo che la direzione del museo dovrebbe cominciare a pensare di più all’esperienza del cliente!”.
La gente ha sempre litigato per Auschwitz. Auschwitz I, il campo di concentramento e successivamente di sterminio, è stato creato in un’ex caserma dell’esercito. Auschwitz II, o Birkenau, dove c’erano quasi tutte le camere a gas e i forni crematori, è a due chilometri di distanza. Auschwitz, Poland, and the politics of commemoration, 1945–1979 di Jonathan Huener (“Auschwitz, la Polonia e la politica della commemorazione, 1945-1979”) racconta che ci sono state proposte di demolire Birkenau o di ospitare sui suoi terreni un circo oppure dei maiali. C’è stato anche il tentativo di dipingere Auschwitz come il punto più basso mai toccato del capitalismo, cosa che sorprenderebbe i molti capitalisti uccisi qui.
Auschwitz-Birkenau è più silenzioso che in passato. Trentacinque anni fa Avraham Weiss, un rabbino di New York, si scagliò contro il convento di suore carmelitane creato in un ex magazzino di Zyklon B – il pesticida usato per uccidere gli ebrei – all’interno del complesso. Giovanni Paolo II ignorò le richieste del comitato per la protezione delle suore carmelitane e ordinò lo spostamento del convento in altro luogo. Il New York Times fece un titolo irresistibile: “Il papa ordina alle suore di andarsene da Auschwitz”. Il museo è stato aperto nel 1947 sotto il patrocinio del ministero della cultura e dell’arte, che ha deciso di creare un museo del martirio polacco perché offriva alla Polonia una narrazione che il paese era in grado di sostenere, non solo uno specchio con il riflesso di un ebreo dallo sguardo carico di rimprovero. E così hanno fatto di Auschwitz I un museo dell’agonia polacca e hanno lasciato crescere l’erba a Birkenau. Questo è sia un bene sia un male.
Durante la mia prima visita, nell’estate del 2021, all’ingresso del campo c’è una mostra di fotografie dei primi detenuti: prigionieri politici polacchi. Ci sono parcheggi, bagni – vedo un ragazzo seduto sulle scale che guarda su Tinder la foto di un perizoma senza una donna dentro – e un ristorante che cerca di darsi un’aria di normalità, con barattoli di grano sulle mensole. Una mosca è finita nel condimento dell’insalata. La mosca ha capito tutto. Si è suicidata.
La mia prima visita è guidata da una bionda abbastanza giovane in abito da cocktail color salmone e sandali argentati. Ci fa fare il giro della mostra, parlando con voce monotona e un’espressione priva di qualsiasi sorpresa. Non riesco ad ascoltare e a prendere appunti nello stesso tempo, quindi non mi ricordo quasi niente di quello che ha detto. Ci mostra tutto: le pile di vasi e stampelle, le scarpe e i capelli umani. Prendo la parola e dico: qualcuno chiede mai dei capelli? Credo che secondo la tradizione ebraica debbano essere sepolti. Risponde che nessuno si è lamentato, a parte gli stretti osservanti. Ci portano al crematorio 1. Non voglio entrare. Un uomo di mezza età mi guarda. È ovvio che è vagamente emozionato all’idea: “Viene?”, mi chiede, e alla fine mi accodo.

Davide Bonazzi
Prendiamo un autobus navetta per Birkenau. Mi fisso sulle cose che lo ancorano qui e lo rendono reale: l’edificio dall’aria familiare sul retro con il tetto rosso acceso (Google Maps mi dice che ci fabbricano trapunte e materiali di cartoleria); la sottile via di accesso; il negozio che vende calamite da frigo con la scritta, piuttosto esplicita per delle calamite da frigo, “Campo di sterminio tedesco di Auschwitz-Birkenau”; la topografia. Il campo è stato costruito ai margini di un villaggio di nome Brzezinka: i discendenti degli abitanti protestano. Hanno appeso un cartello: “Dalle nostre case demolite è stato costruito il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Molti di noi non hanno ancora ricevuto un risarcimento. Siamo vittime dimenticate della seconda guerra mondiale”.
La gente guarda dentro le baracche, schermando gli occhi con le mani. Più tardi lo faccio notare a una donna, che è sopravvissuta ad Auschwitz, e lei mi chiede: “E tu, cosa stai cercando?”. Non lo so, ma ho la sensazione che sia tutta una finzione. Il Magneto bambino dell’universo Marvel? Le Ss goblin? Alla nostra guida interessano soprattutto i bagni (non è insolito: al ghetto di Cracovia la guida mi ha detto di aver avuto il seguente scambio con un turista ad Auschwitz: “Avevano la carta igienica?”. “No”. “Come si pulivano il sedere?”. “Con la mano”. “Quale mano?”. “La sinistra”. “Perché la sinistra?”. “Con la destra mangiavano”. Un ebreo americano una volta gli ha chiesto: “Dov’erano gli avvocati?”. Lui ha risposto: “Nel prossimo vagone merci”. Adoro gli ebrei americani). In sintesi, la nostra guida dice che gli ebrei non avevano bagni. Avevano perso la loro umanità. Il messaggio sottinteso sembra: tenetevi stretta la vostra tazza del gabinetto.
Torno un’altra volta. In estate, se volete venire prima dell’ora del tè (le quattro) dovete pagare ventidue dollari per una visita guidata. Si comincia con un film che ha in sottofondo una musica triste da crociera sul Reno e una voce delirante fuori campo: “I forni potevano bruciare i resti di oltre quattromilasettecento persone al giorno… Fuggire era quasi impossibile… Cosa hanno portato milioni di vite spezzate dall’altra parte del recinto?… La posta in gioco è alta. Quali scelte farete?”. Se fosse messo per iscritto sarebbe tutto in maiuscolo. È come essere presi a pugni in un cartone animato.
Nella mia seconda visita, il tizio che ci fa da guida è tutto pulito e ordinato. Sembra il cattivo di Terminator 2. Stringe l’ombrello con ostentazione. Ha un paio di occhiali da sole a specchio: vediamo il nostro riflesso sulle lenti. Le sue parole crepitano. Una famiglia polacca ha portato un bambino di sei anni. Mi chiedo che idea si sia fatto di tutto questo. La madre dice che gli hanno promesso un gelato alla fine della visita. Ha degli occhiali da sole a forma di cuore.
C’è una fotografia di un gruppo indistinto di donne nude spinte in una camera a gas. Fa parte di una famosa serie di foto scattate dal Sonderkommando – un gruppo di prigionieri, per lo più ebrei, costretti a lavorare nelle camere a gas e nei forni crematori – e fatte uscire clandestinamente dalla resistenza polacca. Non credo che questa foto dovrebbe essere mostrata: un americano grasso la fotografa senza guardarla. Mi sembra tipico. Qualcuno si è preso la briga di fare il modellino di una camera a gas e di un forno crematorio con tanti piccoli ebrei.
Arriviamo ai capelli. È un mucchio più o meno di un metro e ottanta in altezza per diciotto metri di lunghezza. Hanno tutti lo stesso colore sbiadito e sono annodati stretti. È una cosa, e quindi una metafora, anche se inconsapevole. Un uomo mi dice: “Da nessun’altra parte del mondo si può vedere una catasta così grande di capelli umani”. Allarga le mani per dimostrare la grandezza. Il suo amico risponde, come se aspettasse il momento: “I capelli sono un pugno in faccia”. La guida ci dice di non fare foto. L’americano grasso ne scatta una lo stesso. Gli chiedo: “Perché fai la foto se ti hanno detto di no?”. “È più straziante”, dice, con trasporto. Ha gli occhi stralunati, come se fosse da qualche altra parte. “Per dopo”, aggiunge.
Il primo monumento all’Olocausto è stato costruito durante lo sterminio a Majdanek, dove i prigionieri riempivano di ceneri umane delle aquile ornamentali e dicevano ai nazisti che stavano abbellendo il sito (ironia ebraica). Il monumento di qui non ha quello spirito. Lo detesto. Sembra una torre Jenga troppo grande. Forse vuole somigliare ai due forni crematori dismessi ai suoi lati o alla garitta delle Ss. Sembra appartenergli. Mi chiedo se sono la prima persona ad averlo notato. Mi chiedo se sono matta. Ma non sono sorpresa. Il monumento alle vittime ebraiche austriache della Shoah di Judenplatz a Vienna sembra una spa. Il titolo del Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa non cita i nazisti, quindi è possibile che gli idioti del futuro penseranno che gli ebrei tedeschi sono stati rapiti dagli alieni.
Il Monumento internazionale alle vittime di Birkenau è stato inaugurato nel 1967, quasi a metà del dominio sovietico sul paese. Il governo aveva indetto un concorso per il miglior progetto, il bando diceva: “Questo monumento non dovrebbe essere solo un simbolo del martirio e della lotta, ma anche della fratellanza nata nella sofferenza e nella lotta comune”. Ci sono stati sette progetti finalisti, ma sono stati tutti rifiutati. Alla fine, tre gruppi di progettisti sono stati messi a lavorare insieme, tra mille interferenze politiche, e hanno prodotto questo. È un compromesso, e ne ha tutta la malinconia. C’è però una cosa bellissima, una vera barzelletta ebraica. È il refuso di Auschwitz-Birkenau. Le targhe sul monumento originale sono state sostituite perché sovrastimavano le vittime di due milioni e mezzo: forse c’era lo zampino dei nazisti.
Non mi chiedete di questa cosa, dice la guida, non ne so niente. Lo apprezzo per questo, ma rovina tutto dicendoci che i prigionieri del Sonderkommando “facevano una vita piuttosto lussuosa”. Nella baracca qualcuno fa l’immancabile domanda sul bagno: potevano usare il bagno la notte? Non prendo nota della risposta. La guida si lamenta delle “scritte lasciate da visitatori che non sanno come ci si comporta”. La famiglia Levy ha inciso una stella di David vicino all’entrata. Gli chiedo: “Come mai, dopo la Shoah, abbiamo ancora l’antisemitismo?”. So che è una domanda stupida. Una domanda migliore, parafrasando Hannah e le sue sorelle, è: “Come potrebbe essere il contrario?”. La sua risposta: “Loro (gli ebrei) vogliono distinguersi dagli altri. Nell’impero romano c’erano cinquanta divinità. Gli ebrei ne avevano una sola”.
Qualche tempo dopo, torno a Birkenau per conto mio. Mi chiedo se potrò entrare, visto che non ho il biglietto. Ma i cancelli sono incustoditi. Guardo i bambini che corrono lungo i binari verso i forni crematori. L’erba è talmente rigogliosa che la puoi sentire muoversi. Sogno a occhi aperti che sia trasformata in un giardino chiuso a chiave, come sarebbe giusto: restituito a Dio. Perché non c’è alcun simbolismo ebraico nel monumento di Birkenau, nemmeno un’intera civiltà se lo è meritato. Ce n’è qualche traccia a Treblinka, dove il memoriale evoca il muro del pianto, spaccato a metà, ma non ci va quasi nessuno, quindi forse non conta.
Auschwitz, però, è troppo potente per darla agli ebrei. Incontro una turista che è venuta in Polonia per una crociera fluviale ed è rimasta per il campo. “Non sono delusa”, dice, “è raccapricciante”. Io ormai non credo più che Hitler abbia perso la guerra, ma la Polonia si consegna al pensiero magico. Immagino di viaggiare nel tempo e di trovare un mago che li riporti indietro. Penso soprattutto che se non sai cos’è un ebreo quando entri ad Auschwitz-Birkenau continui a non saperlo anche quando esci quindi, qualsiasi altra cosa sia, questo è un monumento alla logistica e a nient’altro.
A Varsavia alloggiamo nella città vecchia, che è stata quasi completamente distrutta dopo l’insurrezione del 1944 ed è stata ricostruita in parte secondo i paesaggi di Bernardo Bellotto, un dipinto sopra un massacro. Il nostro albergo è una residenza seicentesca con vasti contrafforti. All’interno di questo dipinto ho le allucinazioni. M’immagino simboli cattolici portati in piazza da una processione che recita il kaddish anche se, a dire la verità, il mio latino non è un granché. Lo scorso ottobre qui c’è stata una marcia per la Palestina e una studente norvegese ha mostrato un cartello con sopra una stella di David gettata in un cestino. La donna è stata intervistata e ha detto di non essere contro gli ebrei. Mi chiedo se intendesse le statuine giocattolo.
Visitiamo il Polin, il museo della storia degli ebrei polacchi. Dairusz Stola, il suo ex direttore, se n’è andato quando il partito Diritto e giustizia ha rifiutato di riconfermalo al suo posto. Stola era contrario alla legge che vietava le accuse di complicità polacca durante la Shoah e ha organizzato la mostra Estranged: march ’68 and its aftermath (Distanti: marzo ’68 e le sue conseguenze), che ha sottolineato i parallelismi tra la Polonia del ventunesimo secolo e la retorica antiebraica del 1968 che portò all’esodo di tredicimila ebrei polacchi superstiti. Vedo i dipinti contemporanei di Wilhelm Sasnal: una donna passa in auto il cancello di Birkenau, ma non lo guarda. Sasnal dipinge anche il campo di concentramento di Majdanek. C’è un’unica bicicletta, è quella di un turista.
Durante un temporale spaventoso, incontro il giornalista Konstanty Gebert, un esperto di genocidio comparato, nel suo grande appartamento nel centro di Varsavia. Amo la sua casa tappezzata di libri perché ho passato giorni dentro la realtà parallela di Bellotto, uscendo solo per andare al Polin e per vedere un film di Disney al Palazzo sovietico della cultura e della scienza, un’altra realtà parallela.
“Il silenzio di cui stai parlando”, mi dice, “non è esattamente il nostro argomento di conversazione preferito. La Polonia ha perso la guerra. C’è stata fin dall’inizio una relazione estremamente ambigua con il passato di guerra”. Le bugie fanno incetta di voti nazionalisti, o ci provano. Nel 2018, Yair Lapid, oggi leader dell’opposizione israeliana, ha usato la frase “campi di sterminio polacchi”, che è scandalosa. L’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha risposto che ci sono stati anche degli “assassini ebrei” e che ogni ebreo sopravvissuto si è salvato solo perché ha incontrato un polacco. “Se non fosse drammaticamente serio”, dice Gebert, “sarebbe molto divertente. Entrambi questi signori mentono spudoratamente senza nemmeno capire su cosa stanno mentendo, ed entrambi hanno l’opinione pubblica saldamente dalla loro parte”. Fortunatamente c’è ancora speranza per la memoria polacca. Il nuovo governo non ha proposto una sua lettura della storia, dice Gebert. “Lascia che se ne occupino gli storici”.
“La cosa singolare della sofferenza”, aggiunge, “è che non nobilita. Questa è una fallacia cristiana. A livello collettivo, non nobilita. Ti fa concentrare sul tuo dolore e ti rende insensibile e indifferente a quello altrui. Questo è successo in Polonia. Ma non solo in Polonia”. Ogni fazione, dice, crede “che la guerra sia una cosa sua. Tutto il resto è stato una nota a margine. Prova a parlare con i serbi: la guerra era una cosa dei serbi. Con i curdi, poi, è inutile parlarci: sostanzialmente, la storia del mondo è la storia della sofferenza curda”. Ma la storia è un’altra, dice. “La loro psicologia è identica alla nostra. Sentiamo il bisogno di rimarcare la nostra sofferenza, perché se non lo facciamo noi non lo farà nessun altro, e tutto quel sangue sarà stato versato invano”.
“Viviamo in una bolla”, dice Gebert, “dal Regno Unito a Varsavia. Una bolla ricca, protetta. Facciamo solo finta di non rendercene conto”. Il mondo vero non è qui, dice, e ha ragione. Il mondo vero, dice, è a Kiev, a Kabul, a Rafah. “Non siamo riusciti a capire che un mondo con un Auschwitz non può essere riparato. L’ambizione di renderlo di nuovo giusto è sbagliata, ci distoglie dal compito più serio di capire. Succede ogni volta. Le guerre per la memoria, le distorsioni… semplicemente, un genocidio lascia nel cuore del mondo un buco che non può essere riempito”.
Portiamo con noi i sottaceti di Chabad: sono diventati una metafora della nostra nuova vita ebraico-polacca. Naturalmente, facciamo un casino: sul treno per Varsavia il mio compagno fa cadere il barattolo e la carrozza, che è piena di giovani donne bellissime, soffoca per la puzza di sottaceti e tutti si mettono a gridare.
Tanya Gold è una giornalista freelance. Questo articolo è uscito sul mensile statunitense Harper’s con il titolo My Auschwitz vacation.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a:
posta@internazionale.it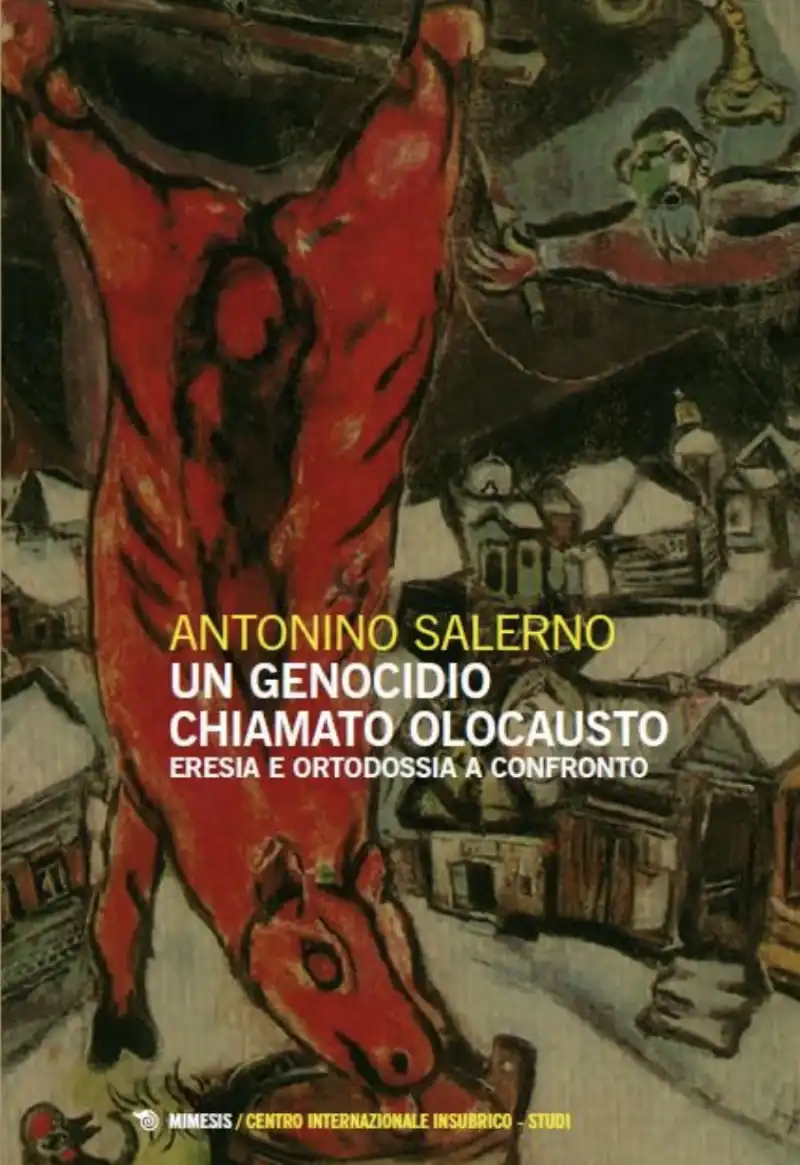 ANTONINO SALERNO - UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO
ANTONINO SALERNO - UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO PRESENTAZIONE LIBRO ANTONINO SALERNO ALL UNIVERSITA DELL INSUBRIA
PRESENTAZIONE LIBRO ANTONINO SALERNO ALL UNIVERSITA DELL INSUBRIA PRESENTAZIONE DEL LIBRO UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO DI ANTONINO SALERNO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO DI ANTONINO SALERNO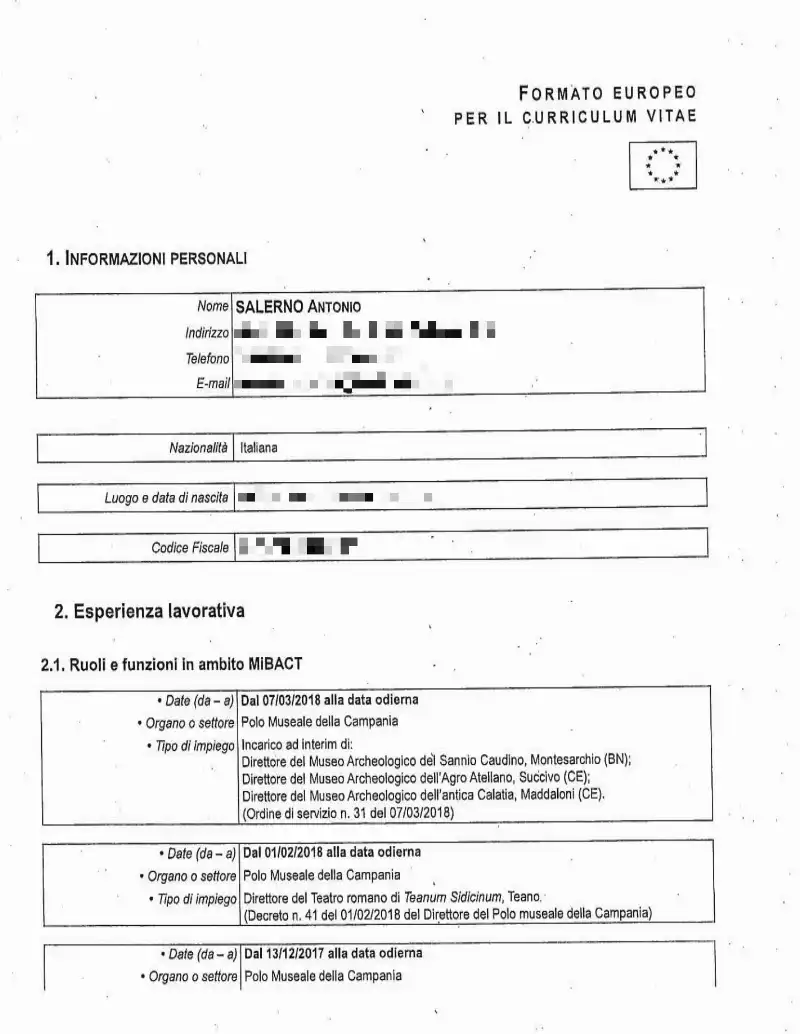 CURRICULUM VITAE DI ANTONIO SALERNO
CURRICULUM VITAE DI ANTONIO SALERNO ebrei nel campo di concentramento di auschwitz 4
ebrei nel campo di concentramento di auschwitz 4 franco cardini - foto lapresse
franco cardini - foto lapresse